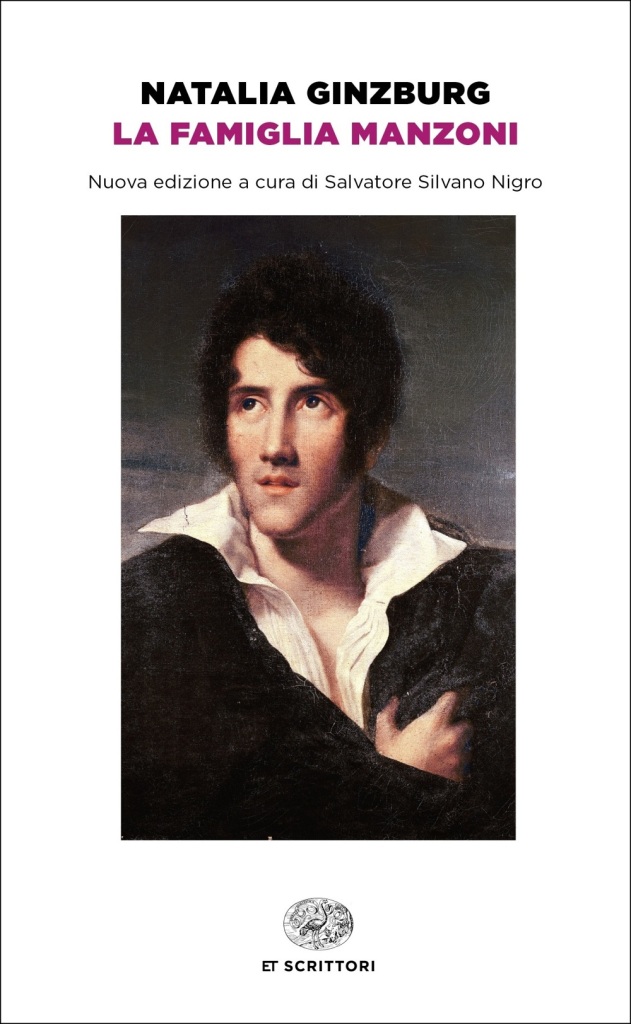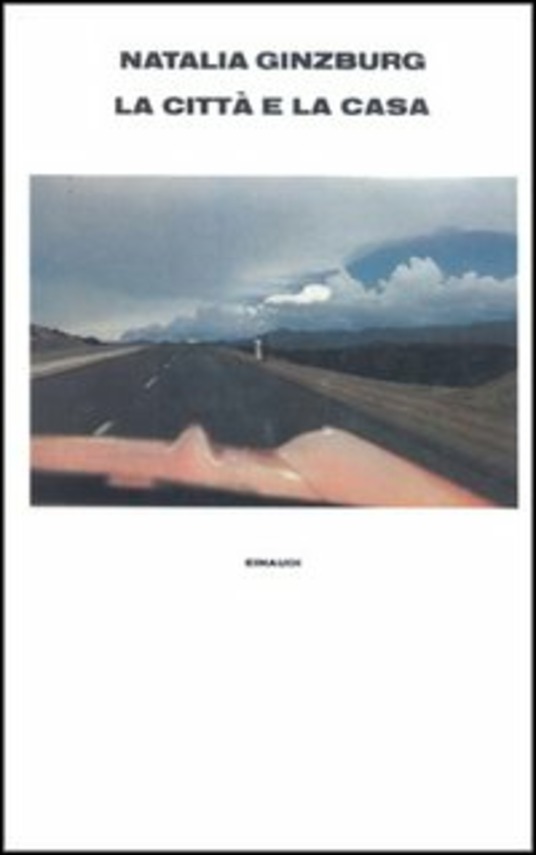domenica 31 ottobre 2021
Terni come Kabul, vietate minigonne e scollature: per il sindaco sono simboli di prostituzione ALESSIO DI SAURO
giovedì 28 ottobre 2021
I talebani hanno spento anche la musica (di W. Samadi)
lunedì 25 ottobre 2021
Come cambia la nostra vita se il lavoro non è più una religione scritto da Riccarda Zezza
Sembra che proprio ciò che funzionava nell’essere parte di una comunità economica abbia smesso di funzionare con il Covid: questo si mormora negli Stati Uniti per spiegare il protrarsi e inasprirsi del fenomeno delle “Grandi Dimissioni”. Le persone hanno scoperto di poter consumare meno e di poter quindi vivere con meno, e questo gli sta consentendo di cercare strade alternative all’idea tradizionale di un lavoro a cui dare tutto: un lavoro che, più che un ruolo, negli ultimi 50 anni aveva finito col diventare un’identità divorante, quasi una religione. Si tratta di un movimento di opinioni e di intenti di cui in Italia arriva solo l’eco, per ora, ma, conoscendo la capacità di colonizzazione culturale degli Stati Uniti, non tarderemo a farne oggetto di dibattito anche qui.
Non c’è da preoccuparsi, ma da riflettere: c’è molto da mettere a posto nel nostro modo di lavorare, e niente come una crisi è efficace per far intuire nuove possibilità anche laddove da decenni le regole sembrano immutabili. Il Covid ci ha fatto sperare in un cambiamento che in fondo in fondo temiamo finirà col non avvenire, mentre già presentiamo e pratichiamo un ritorno alle vecchie abitudini, al traffico, al bisogno di vedersi di persona non solo quando serve ma anche quando “le circostanze lo richiedono”.
Stiamo tornando in trappola? E’ così facile tornare a “oggettificarci”: a vederci come meri strumenti di un sistema produttivo da cui tutti dipendiamo, o così crediamo? Il tema dell’oggettificazione offre una prospettiva interessante su alcune delle grandi sfide di sostenibilità umana che il mondo del lavoro presenta oggi: ne parla il giornalista Arthur Brooks nella sua colonna settimanale su “Come farsi una vita” sull’Atlantic, partendo nientepopodimeno che da Karl Marx.
Marx, ci ricorda Brooks, nel saggio del 1844 “Il lavoro estraniato” diceva che, col sistema capitalistico:
“L’attività spontanea dell’immaginazione umana, del cervello umano e del cuore umano, opera in modo indipendente dall’individuo, appartiene a un altro: è la perdita di sé stesso”.
I lavoratori, conclude Brooks, vengono oggettificati, ridotti a gusci infelici. Il termine oggettificazione viene usato in Italia soprattutto per parlare di discriminazione sessuale:
“L’oggettificazione sessuale od oggettivazione sessuale consiste, in un’accezione perlopiù negativa, nel considerare una persona alla stregua di un oggetto mirato ad appagare desideri sessuali”.
Ma Brooks riconduce il termine a una modalità di considerare le persone, marxianamente, come strumenti di produzione: effetto dell’approccio religioso di cui sopra, in cui il lavoro è un tutto di cui le persone fanno parte e non viceversa.
Eravamo nell’ingranaggio e, come spesso accade in questi casi, non lo vedevamo nemmeno. Ne siamo usciti a causa di un urto violento e improvvisamente lo abbiamo visto. Cosa fare adesso? Intanto è importante che se ne parli: uno dei modi più efficaci di rompere gli stereotipi è quello di portarli alla luce. Ed è molto, molto difficile tornare indietro, smettere di vedere qualcosa dopo averlo visto una prima volta. Poi è utile considerare che risolvere l’oggettificazione risolverebbe anche alcune delle questioni più pressanti che si trovano a gestire le aziende oggi in ambito capitale umano.
1) Quando l’oggettificazione è prodotta dall’ambiente, e quindi è l’ambiente a far sì che la persona che vi entra venga vista in modo parziale e depotenziato, si ha il fenomeno della discriminazione: l’oggettificazione sessuale è un esempio, ma ne esistono molti altri, tanti quanti sono gli ostacoli che ogni forma di diversità sperimenta oggi nel farsi vedere, accettare e valorizzare.
2) Quando l’oggettificazione è prodotta dallo stile manageriale si ha il fenomeno del “boss tossico”, quello che vede, usa e misura le persone come dei meri strumenti di produttività, abbassandone motivazione, benessere ed efficacia. Di questa pratica esiste addirittura un indice che ne misura danni e conseguenze.
3) Esiste però anche l’auto-oggettificazione, ed è forse il fenomeno più insidioso: siamo proprio noi spesso a sentirci e a presentarci come una versione ridotta di noi stessi, identificandoci con la sola dimensione lavorativa. Con quali conseguenze? Proprio quelle che avevamo smesso di vedere pre-covid e che adesso ci appaiono chiare davanti agli occhi: perdita di dimensioni identitarie che ci arricchiscono e ci ricaricano, e quindi perdita di capacità e di risorse di cui la mono dimensionalità ci priva. Si va dall’autostima al senso stesso della propria esistenza, che ovviamente influenza la nostra capacità di sentirci efficaci e agenti attivi nel mondo in cui viviamo.
Nella religione si crede ciecamente, mentre il lavoro è sempre il risultato di scelte che la mobilità futura ci farà mettere in discussione ogni giorno, spingendoci a domandarci chi siamo, quante cose siamo e quanta parte di noi dare ad ognuna. Ognuno di noi diventa così il “tutto” di partenza in cui far entrare dimensioni come lavoro, famiglia, passioni: un’ampiezza di prospettive che può spaventare, ma che ci rende più adatti a vivere la complessità del mondo che ci attende.
venerdì 22 ottobre 2021
"𝐏𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐠𝐨𝐠𝐧𝐚. 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚. 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚".
"𝐏𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐠𝐨𝐠𝐧𝐚. 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐬𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚. 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡é 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚".
Lei è Negin Khpalwak, classe 1997, prima direttrice d’orchestra donna dell’#Afghanistan.
Il suo incontro con la musica è avvenuto all'età di tre anni, in seguito poté continuare gli studi a Kabul ma solo perché il suo villaggio aveva bisogno di un medico donna che curasse le donne. E' a tredici anni che però inizia la sua carriera come musicista con il solo appoggio del padre: il resto della famiglia, i vicini e il suo villaggio l'hanno ripudiata.
“Non accetterò mai la sconfitta. Continuerò a suonare. Perché quando la gente mi vede e dice 'Lei è #NeginKhpalwak' mi riempie di energia”.
A 20 anni diventa la più giovane direttrice d'orchestra del Paese, alla guida della #ZohraOrchestra, il primo ensemble femminile del suo Paese composto da trenta ragazze tra i 13 e i 20 anni, che unisce influenze afghane a quelle occidentali. "Tanti vorrebbero richiuderci nelle case, impedirci di fare musica. Io invece voglio dimostrare ogni giorno che le donne afghane possono fare tutto".
La musica, per Negid, "è un modo straordinario di comunicare, tutti ti capiscono, ovunque, senza bisogno di parlare. Tira fuori i sentimenti, ti commuove". Negli anni la Zohra diventa un esempio di riscatto ed empowerment per le giovani donne oltre che ponte di dialogo tra culture diverse. L'Orchestra ha l'opportunità di esibirsi in tournée in Europa e di fronte a duemila leader mondiali al World Economic Forum a Davos nel 2017.
Questo sogno è stato possibile grazie all’ANIM: Istituto nazionale di musica dell’Afghanistan. In questi 20 anni di occupazione le zone controllate dalle forze occidentali hanno permesso lo sviluppo di progetti artistici sottolineando il ruolo della musica per il processo di democratizzazione.
Con il ritorno dei Talebani la musica è stata nuovamente vietata, l’Istituto è chiuso e Negin Khpalwak ha lasciato il Paese.
https://www.facebook.com/groups/1427604680829903/permalink/3074183722838649
giovedì 21 ottobre 2021
Afghanistan: le donne che conosciamo di Marisa Guarneri
Oltre vent’anni fa con la Cadmi (Casa delle donne maltrattate di Milano) ho incontrato un gruppo di giovani operatrici della casa rifugio di Kabul, l’unico shelter del paese a quei tempi, super controllato e protetto, che accoglieva donne da tutte le città dell’Afghanistan. Facevano da tramite per noi le donne del Cisda (Centro sostegno donne afgane), legato a RAWA. Per una settimana, alla mattina facevamo lezioni e incontri, poi si pranzava insieme – loro mangiavano pochissimo, ricordo – e al pomeriggio facevamo esercitazioni. Raccontavano la loro pratica: stavano con le donne in fuga dalla violenza a lungo, anche per mesi, prima che si creasse la fiducia necessaria a uno scambio verbale, e fino a quel momento c’era solo un rapporto di sussistenza: mangiare dormire accudire bambine e bambine. Loro non forzavano assolutamente niente finché queste donne, questi corpi, non si avvicinavano e solo allora, dopo molto tempo, veniva fuori l’abbraccio, la lacrima anche senza parole.
Le donne afgane esistono
Le afgane sono donne libere che sfuggono all’oppressione sessista e sessuale, alla sharia che le vuole ridurre al silenzio. Non ci sono parole per definire donne coraggiose che salvaguardano ciò che hanno conquistato, mi incazzo per la semplificazione dei politici e dei media che parlano di clandestine come fossero tutte uguali. Dopo gli anni ’70 entrare in clandestinità significa essere terroriste disponibili a usare le armi, mentre dire donne nascoste sembra una resa. In realtà molte sono attiviste, come le madres di Plaza de Mayo fondatrici di una democrazia in Argentina. Sono donne che lottano per esistere, minoranze disconosciute che riescono a ottenere dei risultati importanti per tutti.
I media e i politici occidentali cercano di interpretare le afgane secondo i nostri canoni, sfornando false verità e producendo danni molto forti. Quello che emerge è soprattutto emarginazione, povertà, vedove per strade senza cibo, divorziate, bambine vendute per avere soldi in famiglia… una fascia di miseria femminile che è reale ma non c’è solo questo! Ci sono le donne che fanno impresa, le insegnanti, le giornaliste molto presenti, le studenti, le attiviste, e c’è la differenza tra città e campagna, perché quanto più ci si allontana dalla città tanto più le famiglie sono patriarcali e le donne stanno peggio.
Ogni donna ha fatto percorsi diversi, da quella che è andata via dall’Afghanistan, a quella che è rimasta e ha combattuto, a quella che è rimasta senza il coraggio di combattere, impantanata in situazioni terrificanti.
Le donne afgane non sono una categoria, anche se tutte vogliono tirarsi fuori dalla miseria e dalla fame, e poi viene tutto il resto. Molte sognano di potersene andare, tranne le combattenti; molte fanno parte di associazioni e perseguono obiettivi in modo determinato; alcune sono martiri, come scelta responsabile. In questi ultimi giorni le abbiamo viste manifestare nelle strade, non si nascondono, hanno un coraggio che mi fa venire i brividi. La loro forza riscuote una solidarietà planetaria.
Tutte le donne povere e misere del mondo hanno bisogno di cambiare vita, soprattutto quelle che si sono sedute nello status quo. E aggiungo anche quelle ricche, che hanno un ruolo sociale e si sono sedute nei posticini radical chic. In Italia anche donne ricche, influencer e imprenditrici, hanno usato le loro risorse per salvare delle vite, lo hanno fatto attraverso istituzioni, ministro degli esteri, appelli a Mario Draghi, con un tam tam mediatico, con la forza del denaro e un notevole sfruttamento della propria immagine. Ma poi?
Vittimaio impacchettato
Fare di ogni donna un fascio è un approccio distruttivo, perché di fronte agli interessi politici e finanziari spariscono quelli delle donne.
Sono convinta che ci sia una vera e propria strategia di abbassare tutte e tutti allo stesso livello, quello del pietismo, della lacrima e della commozione, così non ti preoccupi più di capire e fai solo elemosina.
Le vittime non sono più solo vittime, diventano vittime miserabili, accorpate in un impacchettamento vittimistico, banalizzate e ridotte a una categoria. Allora pensi che basti dare da mangiare e dormire, come si fa con i profughi che vengono da altre forme di persecuzione. E intanto non si distingue neanche chi passa il deserto o il mare, chi fa la strada della Bosnia, che è la peggiore, da chi arriva sui barconi.
Il mainstream accomuna tutti, anche la sinistra. Il rischio è che l’accoglienza si trasformi in procedure, cioè in strategie difensive inconsce o consce, per non entrare nella sofferenza altrui. Anche nei nostri centri antiviolenza si corre questo rischio.
È necessario avere autenticità e competenza per aiutare chi soffre, e io mi sento una irriducibile.
Corridoi umanitari?
Penso che non faranno i corridoi umanitari dall’Afghanistan. Se nessuno si impegna a progettare un piano specifico, chi riuscirà ad arrivare in Europa non avrà un percorso privilegiato, resterà anni ad aspettare un permesso di soggiorno che l’Europa non dà.
Senza una pratica della relazione, uno scambio e un progetto politico, si rischia di portare qui le persone e sbatterle da qualche parte. Già si parla di siti abbandonati o ex caserme. C’è un equivoco di fondo: è ovvio che le risorse messe a disposizioni sono positive, ma non bastano. Le donne non hanno solo bisogni materiali, hanno soprattutto bisogno di superare il trauma. La via vincente, sperimentata dai centri antiviolenza, è la relazione tra donne, ascoltare e non decidere sulla loro testa. Accoglierle in questo modo non è un lusso e le donne se lo meritano. Tutte.
*Marisa Guarneri è cofondatrice e presidente onoraria di Cadmi (casa donne maltrattate di Milano)
mercoledì 20 ottobre 2021
Parlamento europeo contro la Pas e ogni forma di vittimizzazione secondaria nelle cause di affido Daniela Poggio
Con 510 voti a favore, 31 contro e 141 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza, lo scorso 6 ottobre, la “Relazione sull’impatto della violenza domestica e dei diritti di affidamento su donne e bambini” proposta dalle commissioni Femm (diritti e pari opportunità) e Juri (giuridica) per proteggere le donne e i bambini in uscita dalla violenza nelle battaglie di affido dei figli minori. Relatrici del testo, Elena Kontoura (The Left – Grecia) e Luisa Regimenti (che dalla Lega è passata a Forza Italia), relatrice ombra per i socialisti l’eurodeputata Pina Picierno. Per l’Italia hanno votato contro Lega e Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia si è astenuta.
Gesto politico importante
L’approvazione di questo testo rappresenta un gesto politico importante che, insieme alla richiesta di inserire la violenza di genere tra gli eurocrimini (già approvata dal Parlamento), mette nero su bianco innanzitutto l’esistenza di un fenomeno, quello della vittimizzazione secondaria di donne e bambini nelle cause di affido, per poi stigmatizzare e censurare l’utilizzo delle pratiche che quel fenomeno lo nutrono in tutta Europa. Nel mirino la famigerata Pas (Parental Alienation Syndrome) e tutti i suoi derivati (madre simbiotica, alienante, fusionale, sleale), in nome della quale bambini, bambine e preadolescenti vengano sottratti, anche con l’uso della forza pubblica, a genitori che amano, per lo più madri, per essere “resettati” e portati in case-famiglia o affidati al genitore che rifiutano – anche in caso di violenza – senza indagarne i motivi. A dire no all’ablazione della maternità, come amano chiamarla i “pasisti”, ora però è l’Unione Europea e tutto fa pensare che sia solo l’inizio della fine di un sistema che ha potuto contare sulla paura e il silenzio a cui venivano costrette le madri che finivano in questi tritacarne giudiziari insieme ai loro figli. E che ora hanno avuto il coraggio di parlare, trovando più ascolto e sostegno.
Cosa dice la risoluzione
La relazione votata dalla Ue parte coraggiosamente da una premessa fondamentale (e pure di buon senso): ossia che la custodia congiunta nei casi di violenza è contraria al supremo interesse dei minori, addirittura rappresenta una violazione dei diritti umani, compreso il diritto alla vita e alla salute, come risulta dal drammatico aumento di femminicidi e infanticidi. Per questo è fondamentale una formazione specifica e continua di tutti i professionisti forensi, medici, psicologici e delle forze dell’ordine, affinché siano consapevoli degli stereotipi e delle discriminazioni di genere e affinché possano decidere sulla custodia dei minori solo dopo una consapevole valutazione della situazione familiare. Il testo chiede di prestare attenzione ai fenomeni di vittimizzazione e colpevolizzazione, per cui paradossalmente sono le vittime a doversi difendere invece degli aggressori: è il fenomeno della cosiddetta “violenza istituzionale” perché sono proprio le istituzioni a impedire alle donne in uscita della violenza di esercitare i loro diritti. Per poter monitorare più facilmente le situazioni a rischio, la risoluzione chiede di affrontare il problema delle denunce anonime e di quelle ritirate successivamente, tramite ad esempio la creazione di un archivio che conservi traccia di tutto (dichiarazioni che non sfociano in denunce, denunce ritirate o archiviate); esprime quindi preoccupazione per la mancanza di fiducia verso le donne che denunciano.
Non riconoscere l’uso della Pas
Infine, il capitolo Pas: si sottolinea come la cosiddetta sindrome da alienazione parentale e concetti simili si fondino su stereotipi di genere verso le donne, incolpando le madri di “alienazione” dei figli verso i padri e screditando le testimonianze dei bambini, con il risultato di metterli in pericolo. La risoluzione chiede, pertanto, agli Stati membri di non riconoscere l’uso di questa cosiddetta sindrome nella pratica giudiziaria e di proibirne l’uso nei procedimenti giudiziari, specialmente ma non solo nei contesti di violenza, e di formare tutti i professionisti coinvolti nel settore, da quelli forensi ai servizi sociali, medici e psicologici, nonché di informare il pubblico su questo tema. A questo si collega il riferimento alla violenza economica, perché spesso (salvo eccezioni evidentemente e contrariamente alla narrativa dominante di questi anni che voleva i padri separati alla mensa della Caritas, notizia smentita dalla Caritas stessa), sono le donne a diventare più povere in seguito a separazioni e divorzi. Non solo, la non indipendenza economica spinge alcune di loro a non denunciare per paura della povertà, il che rende necessarie decisioni rapide ed efficaci che garantiscano i diritti di mantenimento dei bambini. Infine, il testo torna sulla importanza della Convenzione di Istanbul, non ancora ratificata da tutti gli Stati membri, e della “Gender Equality Strategy” della Commissione per contrastare la struttura patriarcale della nostra società. E poiché violenza chiama violenza, il testo si concentra anche sulla opportunità di introdurre programmi di prevenzione che educhino i bambini alla corretta affettività, contrastando stereotipi sessisti e misogini con i valori dell’uguaglianza, del rispetto reciproco, della soluzione non violenta dei conflitti.
E in Italia?
Anche in Italia, grazie al lavoro della Commissione Femminicidio del Senato presieduta da Valeria Valente, sono emerse importanti criticità nel riconoscimento della violenza domestica nelle cause di affido dei minori. Grazie a questo lavoro, è stato possibile per Valente presentare un pacchetto di emendamenti alla riforma del processo civile voluto dalla ministra Cartabia che consentirà di riconoscere la violenza contro le donne anche nel processo civile, e non solo in quello penale, a partire dalle cause di separazione e divorzio; oltre al divieto di vittimizzazione secondaria. Insomma, niente più sentenze secondo cui una donna abusata, stuprata o uccisa se l’è cercata. Non solo, i magistrati dovranno ascoltare e rispettare la volontà espressa da bambini e ragazzi, anche sotto ai 12 anni, che rifiutano di vedere un genitore; potranno avvalersi se necessario di professionisti specializzati, ma non potranno delegare ad altri i colloqui, che saranno sempre videoregistrati; i consulenti dovranno attenersi alle metodologie riconosciute dalla comunità scientifica (no Pas e consimili, insomma). Infine, l’uso della forza pubblica per eseguire eventuali sentenze di allontanamento di minori dalla propria casa dovrà avvenire solo in caso di rischio di vita del minore. Segnali incoraggianti, che sembrano essere stati recepiti anche dall’ultimo documento del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, un testo che complessivamente fa un deciso passo avanti nel riconoscimento della violenza domestica nelle cause di affido, nonostante qualche tentativo un po’ scomposto di sminuirne pubblicamente la portata.
Ma i prelievi dei minori continuano
Se quindi il quadro normativo e istituzionale sta assumendo la forma di una maggiore tutela per le donne in uscita dalla violenza e i loro figli, le peggiori pratiche, che dieci anni di insegnamento della Pas e di alimentazione di un sistema che ruota intorno alla Pas ci hanno regalato, non accennano a fermarsi. Proprio mentre in Europa veniva approvata la risoluzione di cui scriviamo, in Italia un altro bambino, lo chiameremo C., è stato portato via dalla mamma, preso per mani e piedi da dieci persone tra assistenti sociali e forze dell’ordine: una scena raccapricciante che ha fatto il giro della rete e che personalmente non mi ha fatto dormire, cosa che spesso mi capita quando penso a questi bambini. Un altro caso di Pas, di madre considerata ostativa verso un padre che aveva riconosciuto il figlio cinque anni dopo la nascita. Questa mamma non è l’unica che sta vivendo il rischio di “ablazione” dopo il riconoscimento tardivo del padre, e conosciamo bene almeno anche un’altra storia che non sta prendendo una bella piega. Perché – ho scoperto – mentre la madre ha un tempo limitato per riconoscere il proprio bambino o la propria bambina (due mesi!) e può non essere ritenuta idonea, il padre può decidere quando vuole di “tornare sui suoi passi”, come se nulla fosse, e viene riconosciuto automaticamente, salvo opposizione della madre. Un fenomeno su cui prova a intervenire la proposta di legge sugli affidi promossa dalla deputata Boldrini che, con buon senso, dice che il riconoscimento tardivo non può essere accolto in automatico, ma deve essere vagliato dal giudice tenendo in considerazione se questo riconoscimento sia nell’interesse supremo del minore o meno, anche in considerazione della storia pregressa.
Sulla giusta strada
In conclusione, sia in Europa sia in Italia la strada imboccata è quella giusta, ma dobbiamo essere consapevoli che sarà una strada lunga e tortuosa, perché la resistenza a non intaccare le fondamenta della famiglia tradizionale basata sul potere del pater familias è ancora molto radicata nel nostro Paese. E non solo nel nostro Paese. E nelle more del principio apparentemente progressista della bigenitorialità, si sono di fatto avanzate pratiche e proposte di legge ostili alle grandi conquiste femminili, come il diritto al divorzio. Un fenomeno che non viene ancora visto e censurato come si dovrebbe, e che spiega perché un prelievo come quello accaduto nelle scorse settimane non abbia trovato né spazio in prima pagina in nessun giornale italiano né nelle parole di nessuna delle ministre donne di questo governo.
martedì 19 ottobre 2021
Scuola, al mondo 129 milioni di ragazze escluse dall’istruzione scritto da Alley Oop
Una bambina fuori dalla scuola è già una bambina di troppo. In Afghanistan è il 23esimo giorno senza scuola per le bambine della secondaria. Ma il problema non è solo nel Paese in mano ai talebani. In tutto il mondo, 129 milioni di ragazze non vanno a scuola, di cui 32 milioni in età da scuola primaria, 30 milioni in età da scuola secondaria inferiore e 67 milioni in età da scuola secondaria superiore. Nei Paesi colpiti da conflitti, le ragazze hanno oltre il doppio delle probabilità di non andare a scuola rispetto alle ragazze che vivono in paesi non colpiti.
A livello globale solo il 49% dei Paesi ha raggiunto la parità di genere nell’istruzione primaria. A livello secondario, il divario aumenta: il 42% dei Paesi ha raggiunto la parità di genere nell’istruzione secondaria inferiore e il 24% nell’istruzione secondaria superiore. Le ragioni sono molte: le barriere all’istruzione delle ragazze – come la povertà, matrimoni precoci e violenza di genere – variano tra le diverse Nazioni e al loro interno fra le diverse comunità. Ma come primo fattore c’è certamente una scelta delle famiglie: in situazioni di povertà sono i ragazzi quelli su cui si tende a investire in tema diistruzione.
L’Unicef e la digital generazion
In occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, l’Unicef quest’anno dedicata al tema ‘Digital generation. Our generation’. Dal report presentato emerge che nei Paesi a medio e alto reddito, solo il 14% delle ragazze che hanno ottenuto i migliori risultati in scienze o matematica si aspettavano di lavorare nel campo della scienza e dell’ingegneria, rispetto al 26% dei ragazzi con i migliori risultati. A livello globale, solo il 22% dei professionisti dell’intelligenza artificiale (AI) sono donne, un enorme divario di genere che è attualmente al centro della progettazione degli algoritmi che hanno un impatto su tutte le nostre vite.
Nel mondo la percentuale di donne tra i laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (Stem) è inferiore al 15% in oltre due terzi dei Paesi e che il divario di genere tra gli utenti globali di Internet sta crescendo, dall’11% nel 2013 al 17% nel 2019, ed è più ampio nei paesi meno sviluppati del mondo, al 43%. Promuovere l’uguaglianza di genere significa garantire maggiori opportunità alle bambine e alle ragazze per colmare il gap rispetto ai loro coetanei maschi, significa attuare un cambiamento culturale globale che si traduca concretamente in equità salariali uomo-donna, opportunità, sicurezza, protezione sociale, uguali possibilità di accedere all’istruzione per bambine e ragazze. Noi dell’Unicef continueremo a lavorare perché questo avvenga”, ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia.
Non solo scuola
Nel mondo 77 milioni di ragazze convivono con un disturbo mentale diagnosticato, secondo le ultime stime disponibili, contenute nel recente rapporto Unicef. Per le ragazze fra i 15 e i 19 anni il suicidio rappresenta la terza causa di morte più comune, mentre per i ragazzi nella stessa fascia di età è la quarta più comune. A pesare inoltre sul presente e sul futuro delle bambine e delle ragazze ha contribuito anche la pandemia da COVID-19 che sta profondamente colpendo le loro vite. Le restrizioni ai viaggi e il distanziamento sociale, dovuti alla pandemia, rendono loro difficile accedere ad assistenza sanitaria, servizi sociali e supporto delle comunità, che le proteggono da matrimoni precoci e violenza di genere. Con le scuole chiuse, le ragazze hanno maggiori probabilità di lasciare gli studi e non tornare a studiare. La perdita di lavoro e la crescente insicurezza economica potrebbero anche spingere le famiglie a far sposare le loro figlie per alleviare la pressione economica.
Nel mondo, oggi, vivono 650 milioni di donne e ragazze che sono state date in sposa da bambine – circa la metà di questi matrimoni sono avvenuti in Bangladesh, Brasile, Etiopia, India e Nigeria. Anche prima della pandemia da Covid-19, 100 milioni di ragazze entro il 2030 erano a rischio di matrimonio precoce, nonostante le significative riduzioni in diversi paesi negli ultimi anni. Negli ultimi 10 anni, la percentuale di giovani donne a livello globale che sono state date in sposa da bambine è diminuita del 15%, da circa 1 su 4 a 1 su 5, l’equivalente di circa 25 milioni di matrimoni evitati, un traguardo ora messo in pericolo. Secondo uno studio dell’Unicef, a causa degli effetti della pandemia da Covid-19, entro il 2030 potrebbero verificarsi ulteriori 10 milioni di matrimoni precoci, minacciando anni di progressi nella riduzione della pratica.
martedì 5 ottobre 2021
A un mese dal ritiro, la cancellazione delle donne afghane è compiuta By Giulia Belardelli
Annullare la loro presenza nello spazio pubblico è il risultato più concreto raggiunto dai talebani. Le analisi di Fabbri (Limes) e Battiston (Ispi)
A un mese dal ritiro delle truppe occidentali da Kabul, la mortificazione delle donne afghane si conferma al primo posto tra le priorità del governo talebano. In appena trenta giorni, i talebani hanno imposto alle donne una lunga serie di divieti: non possono più accedere all’istruzione secondaria; non possono più frequentare l’università, né come docenti né come studentesse; non possono svolgere la maggior parte dei lavori; non possono praticare sport che ne espongano il corpo. Il loro corpo deve sparire, nascosto sotto pesanti strati di tessuto fino a soffocare ogni desiderio di libertà. Non c’è spazio per loro nel governo, negli uffici, nei luoghi che furono di incontro e cultura. Il loro posto è tra le mura domestiche, dove anche i rapporti familiari risentono del clima oscurantista riportato in auge dai nuovi padroni di Kabul.
La musica tace, mentre tornano le esecuzioni capitali, i cadaveri esposti nelle piazze, le frustrate ai giornalisti, le intimidazioni a chi fino a ieri si era ritagliato un ruolo nella società afghana. Come le 220 giudici costrette a vivere in luoghi segreti perché oggetto delle minacce talebane: durante la loro carriera hanno fatto condannare centinaia di uomini per stupri, violenze, femminicidi; oggi quegli uomini sono liberi e danno loro la caccia, in cerca di vendetta. Nel giro di poche ore, da avvocate e magistrate sono diventate ricercate speciali, prede di quella violenza che per anni hanno cercato di contrastare.
Il resto del mondo, intanto, sembra già annoiato dal dramma afghano. “Tra elezioni tedesche, caso Morisi e altri discorsi astratti sulla difesa europea, l’attenzione dei media si è quasi completamente distolta dall’Afghanistan”, commenta Dario Fabbri, consigliere scientifico e coordinatore America di Limes. Il mese scorso, parlando con HuffPost, aveva previsto che sarebbe successo ma non così presto. Eppure, le notizie che arrivano dall’Afghanistan, dove la libertà di stampa è già un ricordo lontano, non hanno nulla di rassicurante. Vale la pena di ripercorrerle, soprattutto ora che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato una data – il 12 ottobre – per il tanto atteso G20 straordinario sull’Afghanistan.
Per la maggior parte delle donne afghane, il bilancio di questo primo mese “senza invasori” non potrebbe essere più amaro. “Il cambiamento è stato drammatico per moltissime donne, in particolare per quelle che in questi anni si erano conquistate spazi di presenza e agibilità nello spazio pubblico”, commenta Giuliano Battiston, ricercatore Ispi ed esperto di Afghanistan. “Le direttive ufficiali, insieme a tante dichiarazioni che non hanno ancora ricevuto l’ufficialità da parte della leadership talebana, vanno tutte in una direzione: progressivamente, impedire che le donne occupino, come hanno fatto in questi anni, lo spazio pubblico e fare in modo che ritornino dentro le mura della casa. Questo vale per tanti settori, a cominciare dall’accesso al mondo del lavoro: i talebani, come fecero già negli anni Novanta, dicono che non ci sono le condizioni di sicurezza per le donne. In qualche modo, questa politica è presentata come una forma di tutela delle donne. È vero che in alcuni settori - in particolare quelli più vulnerabili in questo momento, come la sanità – alle donne è permesso di tornare al lavoro, ma non tutte lo hanno fatto, e ovviamente il contesto è molto diverso. In tanti altri ambiti, le donne devono in pratica rinunciare a ciò che hanno fatto finora: penso alle imprenditrici, alle donne che hanno lavorato nei ministeri, a quelle impegnate nel ministero per gli affari di genere, che è stato chiuso e sostituito con il ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio”.
Lo stesso discorso vale anche per la libertà di movimento: dentro le città, in particolare, le donne sono sempre più restie ad attraversare i centri urbani; si sentono minacciate, si sentono vulnerabili. “Bisogna tenere presente – spiega Battiston - che le città sono controllate da militanti talebani in buona parte giovani e inesperti, non abituati a rapportarsi con le donne; di questo sono consapevoli anche i leader del movimento, che hanno emesso ammonimenti formali verso i militanti di più basso rango affinché si comportino in modo appropriato. Questa però è anche una scusa che la leadership adotta per posticipare – fino a quando non si sa – il ritorno delle donne negli spazi pubblici e nel mondo del lavoro”.
Al momento il diritto delle ragazze all’istruzione è una favola a cui non crede più nessuno. Alle bambine è permesso di andare a scuola solo fino alle elementari. Le scuole medie e superiori sono inaccessibili. Sull’università la parola definitiva è quella del nuovo rettore dell’ateneo di Kabul, Mohammad Ashraf Ghairat: “Le donne dovranno stare a casa. Lavoreremo duramente per creare presto un sicuro ambiente islamico”. E ancora: “Come rettore dell’università di Kabul, vi do la mia parola: finché un ambiente davvero islamico non sarà fornito a tutti, alle donne non sarà permesso venire all’università o lavorare. Islam first” (prima l’islam, facendo il verso a Donald Trump).
Nel caso della scuola – prosegue Battiston - “non c’è un divieto esplicito: non si dice ‘le ragazze non possono studiare’, si è detto ‘i ragazzi devono tornare a studiare’, quindi facendo un bando implicito ma concreto. Un altro elemento che riduce l’accesso delle ragazze all’istruzione è che non potrebbero avere dei docenti di sesso maschile, e non ci sono abbastanza insegnanti donne. Oggi c’è una parte del corpo docente che ha rinunciato al proprio lavoro: tante lettrici, assistenti, ricercatrici in tante università che oggi sono intimidite, hanno lasciato il paese o sperano di farlo, mentre aspettano di conoscere le nuove direttive del governo”.
Un recente rapporto di HRW riporta le testimonianze anonime di alcune attiviste di Herat: raccontano molto bene come in pochissime ore la loro vita si sia trasformata, sia nelle pratiche quotidiane sia negli spazi domestici. “Si tratta di un aspetto più difficile da cogliere per noi che siamo lontani – osserva il ricercatore - ma il ritorno dei talebani ha in qualche modo galvanizzato e dato una sponda a quella parte più conservatrice e bigotta della società che è sempre esistita. Anche nelle famiglie i rapporti sono cambiati: cugini, zii, fratelli si sentono legittimati a resuscitare le posizioni più oscurantiste”.
Secondo Fabbri, le donne sono le principali vittime di un braccio di ferro, quello in corso tra i talebani e la comunità internazionale. “A un mese dal ritiro delle truppe occidentali, i talebani hanno la convinzione di essere indispensabili per evitare il collasso del paese, la prospettiva che più spaventa quasi tutti i soggetti coinvolti: hanno varato un governo che non tiene conto in alcun modo delle pressioni internazionali; hanno proibito alle donne di studiare e lavorare; hanno picchiato e frustrato i giornalisti, represso qualsiasi manifestazione di dissenso. Al momento non ci sono stati riconoscimenti ufficiali né sono stati sbloccati i flussi finanziari: è in corso un braccio di ferro dall’esito ancora incerto”, argomenta l’analista. I talebani tirano la corda, convinti come sono del bluff della comunità internazionale: sanno che l’idea di una guerra civile e di una popolazione ridotta alla fame significa instabilità e profughi, uno scenario che preoccupa i paesi vicini molto più di qualsiasi rassicurazione disattesa.
Per Battiston, i talebani hanno un problema di tenuta: se si mostrano troppo flessibili, perdono una parte dei propri affiliati e militanti; se si mostrano troppo ortodossi, perdono la possibilità di un rapporto con la comunità internazionale che per loro invece è vitale. Un segnale, anche se minimo, è venuto con le seconde nomine (viceministri e sottosegretari) dove sono stati inclusi rappresentanti delle minoranze ma anche tecnocrati (persino uno con un dottorato). L’inserimento di qualche competenza è stato un tentativo di venire incontro alle richieste di Pakistan, Cina, Qatar. Di donne, ancora una volta, nemmeno l’ombra: la loro cancellazione dallo spazio pubblico resta il più grande “risultato” finora raggiunto dal nuovo Emirato islamico.
lunedì 4 ottobre 2021
ANALISI RAGIONATA DELLA PRODUZIONE LETTERARIA DI NATALIA LEVI GINZBURG, A TRENT’ANNI DALLA SCOMPARSA di Laura Candiani
Nata a Palermo il 14 luglio 1916, vive buona parte della vita a Torino iniziando precocemente a cimentarsi con la scrittura. Dopo il diploma liceale, frequenta l’università ma interrompe gli studi senza laurearsi. Nel 1938 sposa l’intellettuale antifascista e docente di Letteratura russa Leone Ginzburg, a breve lo seguirà al confino, intanto dall’unione nascono due figli e una figlia. Per la sua attività svolta a Roma durante la Resistenza, Leone viene catturato e sottoposto a torture, per cui muore il 5 febbraio 1944. La scrittrice nel dopoguerra lavora a lungo alla redazione della casa editrice Einaudi con cui mantiene nel tempo un fruttuoso sodalizio, intanto scrive romanzi e racconti, fa traduzioni, collabora a riviste e quotidiani. Nel 1950 sposa l’anglista Gabriele Baldini che la lascerà vedova nel 1969. Per lei inizia una fase di maggiore impegno sociale e politico, tanto che fra il 1983 e il 1987 sarà deputata per il Partito comunista italiano. Muore a Roma, dove viveva da tempo, l’8 ottobre 1991.
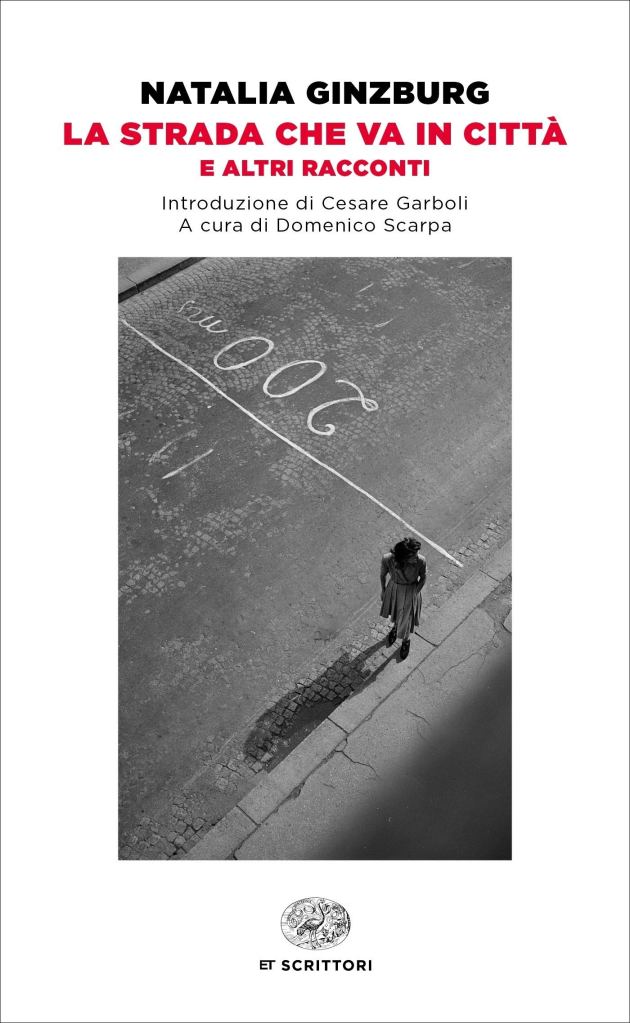
L’opera di esordio di Natalia Levi Ginzburg è il romanzo breve La strada che va in città, scritto a soli 24 anni e pubblicato da Einaudi nel 1942 con lo pseudonimo di Alessandra Tornimparte, ristampato tre anni dopo con il suo nome. È la storia di una ragazza di campagna che vuole emanciparsi, cercando nella città la sua via di fuga e la trova in un matrimonio di interesse, senza amore. Proprio durante la scorsa estate un adattamento teatrale è stato portato in scena dall’attrice Valentina Cervi per la regia di Iaia Forte.
È stato così (Einaudi, 1947; premio letterario Tempo) è ancora un romanzo breve da cui è stato tratto un film per la tv in due puntate diretto da Tomaso Sherman nel 1977. L’opera fu composta a Torino e vi si colloca, con buona probabilità. Di nuovo al centro troviamo una giovane donna, sposata senza gioia, legata ad un uomo infedele; già emergono alcuni caratteri della scrittura di Ginzburg: asciutta, sintetica, oggettiva ma attenta alla psicologia dei personaggi femminili, immersi nella banalità della vita quotidiana.
Tutti i nostri ieri (Einaudi, 1952) è un romanzo ben più ampio dei due precedenti, ambientato fra il fascismo e la fine della Seconda guerra mondiale, in due diverse località italiane, al nord e al sud. La nota sul retro di copertina avverte: «qui la voce [narrante] è fissata in una specie di immaturità attonita e sorda, e un’unica cadenza, quasi un canto monodico, percorre tutto il libro». È proprio così: le pagine si susseguono dense di nomi, personaggi, piccoli fatti senza storia, quasi del tutto prive di dialoghi, «tra le proposizioni indirette di un flusso sintattico rudimentale» e, a lungo andare, una certa monotonia prende il sopravvento, tanto che l’opera non risulta pienamente convincente.

Valentino (Einaudi, 1957; premio Viareggio) è un libro che contiene tre storie: la prima è il racconto lungo in cui la voce narrante è Caterina, una modesta insegnante sorella di colui che dà il titolo e diviene il vero protagonista. Su di lui c’erano tante aspettative in famiglia, invece si rivela un fallito e un mantenuto che ha trovato la sua occasione d’oro sposando una donna più vecchia, brutta, grassa, ma ricchissima. Si è inoltre legato, in maniera ambigua, a un individuo suo pari, un inglese di nome Kit. Quando la sorte cambia, Caterina rimane comunque al suo fianco, presenza amorevole e disinteressata nei cui atti e pensieri si svelano il lirismo e la fine capacità introspettiva della scrittrice. Il secondo racconto, assai breve, ma molto bello, La madre, è incentrato all’interno di un nucleo familiare in cui una giovane mamma, rimasta vedova, finisce con il suicidarsi di fronte al suo personale “male di vivere”. Inadatta e fragile, «si faceva imbrogliare dal macellaio e filava via in bicicletta, e fumava e sbagliava le strade e singhiozzava di notte»; ben presto fu per i due figli solo un lontano e vago ricordo. Il terzo, quasi un romanzo, si intitola Sagittario. Di nuovo una ragazza, ventitreenne, studente di Lettere parla della propria famiglia, che vede al centro la madre, iperattiva e piena di idee, insieme alla sorella Giulia con il marito medico. Una ampia analessi narra i precedenti: la vedovanza, la noiosa vita a Dronero, la fragilità della giovane, le premure del bravo dottore polacco, le loro nozze senza amore, il trasferimento in città. Il titolo merita una spiegazione: questo nome dovrebbe essere dato all’attività vagheggiata dalla madre, una galleria d’arte, da realizzare in società con una donnetta con «la zazzera color fieno», conosciuta da poco, con ambizioni di pittrice. Fra chiacchiere, incontri, piccoli episodi quotidiani, personaggi per lo più femminili dalle esistenze mediocri, nella assoluta mancanza di dialoghi, la vicenda assume verso l’epilogo toni tragici: la signora Fontana era una imbrogliona esperta e ruba i soldi della madre (che non ha nome), quei cinque milioni che dovevano servire per aprire la galleria, e Giulia muore nel parto. «Con le labbra spianate in un vago sorriso gentile e malinconico, Giulia sembrava dire addio a questa vita che non era stata capace di amare». Mentre osserva il nipotino, «rosso rosso, con lunghi e biondi capelli polacchi», la madre finalmente capisce il senso del perenne sorriso sul volto della figlia, giudicata incapace, passiva, inconcludente, era il sorriso di chi vive in disparte e desidera solo ritornare nell’ombra. Un finale dunque che in qualche modo riscatta la donna e, ancora una volta, fa emergere l’abilità della scrittrice nel penetrare a fondo nell’animo femminile.
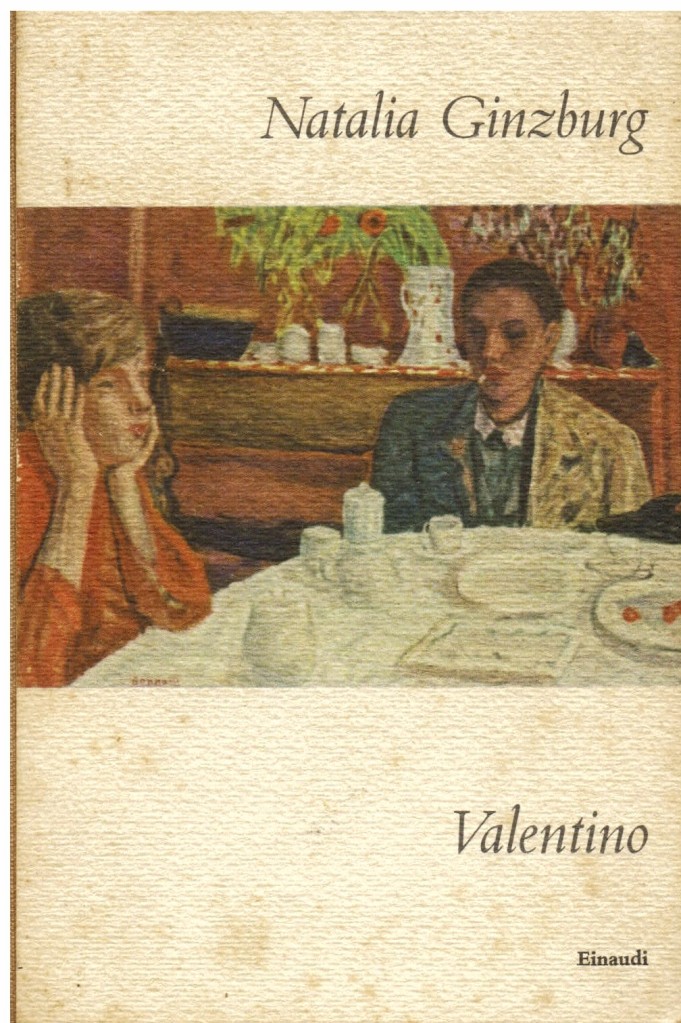
Le voci della sera, uscito nel 1961 da Einaudi, precede di due anni l’opera più compiuta e memorabile di Ginzburg che nel corso del tempo non mi sono stancata di rileggere, con gusto sempre rinnovato. Questo romanzo breve per certi versi la anticipa, pur essendo di totale fantasia, come afferma l’autrice: luoghi immaginari, personaggi immaginari che però dice di aver amato molto, «come fossero veri». La anticipa nei vivaci dialoghi, nell’ambientazione in paesini del nord Italia (Piemonte?), nelle precise descrizioni, nelle divertenti espressioni popolari («sei sempre una ciula», «quel babbaccio là», «vecchia bergianna», «martuffio»), nei personaggi curiosi e originali, come il padrone della fabbrica tenacemente socialista o suo figlio, che più che suonare «bela». Insistito poi l’uso, tutto settentrionale, dell’articolo con i nomi propri: «Dopo la Gemmina, il Vincenzino. Poi il Mario, la Raffaella, e ultimo il Tommasino». Anche qui la voce narrante è in prima persona, femminile: una ventisettenne laureata in Lettere che vive ancora con i genitori, di cui sapremo il nome, Elsa, solo a pagina 85. È lei dunque che ci racconta delle famiglie note dei dintorni, del fratello e della sorella che vivono in due diversi continenti, della banalità dell’esistenza quotidiana, di cosa accadde durante e dopo la guerra; di sé comincia a parlare a pagina 82, svelando la relazione con Tommasino, tenuta segreta. I due arrivano a un passo dal matrimonio, ma poi si rendono conto di non essere felici insieme e si lasciano. Ha sintetizzato efficacemente Pietro Citati: «Ma, come sempre, il più lieve e lieto dei suoi libri è anche quello dove lo strazio è più profondo, dove l’elegia si piega più accoratamente sulle cose che si perdono, sui sentimenti così fragili che muoiono, appena qualcuno li porta alla luce».

Nel 1962 viene dato alle stampe da Einaudi un volumetto esile, ma gustoso: si tratta di Le piccole virtù che raccoglie saggi e articoli già apparsi qua e là, tuttavia piuttosto aderenti al genere della narrativa. Di ciascuno è essenziale conoscere la data e il luogo di composizione dal momento che vi si legano in modo indissolubile; citiamo come esempio il primo che risale al lontano 1944 e ricorda il tempo appena vissuto in Abruzzo, al confino, in un paese misero dove esistevano solo due stagioni: l’inverno e l’estate. Episodi semplici, vita di ogni giorno, la guerra, il proprio mestiere, la forza del silenzio, le piccole e le grandi virtù da tramandare, scarpe vecchie e rotte da un lato ed elogio dell’Inghilterra, Paese «altamente civile», dall’altro. Ma voglio segnalare almeno due perle di questa collana: un racconto mi è capitato di farlo conoscere alle mie classi come esempio straordinario e umoristico di antitesi all’interno della coppia (Lui e io), l’altro perché è quanto di più bello sia stato scritto dell’uomo Cesare Pavese (Ritratto d’un amico); anche solo queste poche pagine valgono la lettura.

Nel 1963 arriva dunque l’opera più amata, nota, apprezzata della scrittrice: Lessico famigliare che le valse il premio Strega; un libro di memorie, ancora una volta pubblicato da Einaudi, dove ciò che viene narrato è vero e reale, ma segue l’onda instabile e vaga dei ricordi, «con vuoti e lacune», «esili barlumi e schegge», tuttavia è pur sempre la storia della sua famiglia. Basta la prima pagina per entrare nel vivo di un nucleo familiare in cui il padre, il prof. Giuseppe Levi, ha un ruolo fondamentale per i suoi comportamenti, le sue bizzarrie, il suo aspetto, il suo linguaggio originalissimo che fa da filo conduttore dell’intero sviluppo narrativo. «Malagrazie», «sbrodeghezzi», «potacci», «loghi», «sempio», «negro» (nel senso di impacciato, goffo), «negrigura»: sono alcune delle curiose espressioni utilizzate per rimproverare, guidare, raddrizzare la moglie, i tre figli, le due figlie, la cameriera. Le amiche di Lidia, la moglie che ama circondarsi di giovani spose, sono «le babe» per le quali va comunque preparato del «trattamento» (tè e biscotti, rigorosamente niente alcol), le chiacchiere sono «fufignezzi», i quadri di Casorati «sgarabazzi»: un lessico unico, esclusivo della famiglia, che fa scrivere all’autrice: «Una di quelle frasi o parole, ci farebbe riconoscere l’uno con l’altro, noi fratelli, nel buio d’una grotta, fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino». Sicuramente questo aspetto è centrale nel testo, ma non è certo l’unico: spesso le situazioni sono umoristiche o risolte in tal modo (come le sfiancanti gite in montagna), i dialoghi sono vivacissimi e modellati chiaramente sul parlato quotidiano, ricordi e aneddoti si fondono con episodi legati alle vicende dell’epoca. Di tutto ciò infatti Natalia è testimone, una spettatrice nell’ombra che osserva e commenta in prima persona, fino dalla giovinezza, e si trova a raccontarci di personaggi della cultura, della politica, della storia che ormai appartengono a tutti/e noi: da Cesare Pavese a Carlo Levi, da Turati ai fratelli Rosselli, dalla famiglia Olivetti a Einaudi, da Pajetta al suo futuro marito Leone. Qui si vive all’interno di una realtà colta, cittadina, agiata, nel cuore di Torino, con un padre docente universitario di Anatomia, fra amicizie e parentele tenacemente antifasciste, ma del pericolo imminente talvolta si sente una eco, che diventerà concretezza ineluttabile quando Natalia si troverà moglie e madre, fino alla tragedia che sconvolgerà le singole esistenze e l’intero Paese.

Caro Michele (Mondadori, 1973), da cui è stato tratto il film di Mario Monicelli del 1976 con Mariangela Melato, è una sorta di romanzo epistolare, con pochi raccordi narrativi, ambientato fra 1970 e 1971. Si apre con Adriana che scrive a Michele, il figlio di 22 anni, esortandolo a visitare il padre malato, da cui è separata da tanto tempo; lei si è da poco trasferita in una casa isolata, in campagna, con le figlie gemelle adolescenti, mentre altre due figlie sono più grandi e già autonome. Nel susseguirsi della storia, in cui comunque gli eventi sono pochi e dettati dalla quotidianità, si trovano via via le risposte di Michele e le lettere di altri personaggi. Incontriamo Mara (che ha appena avuto un bambino, forse figlio di Michele), una sbandata senza casa e senza legami, in cerca di protezione e aiuto; scrive poi Osvaldo, un amico; scrivono le figlie maggiori: Angelica e Viola; scrivono pure conoscenti occasionali. Quando il padre muore, Michele è lontano, vive a Londra: è un ragazzo inquieto, senza ideali, senza un lavoro. Si trasferisce in seguito a Leeds, dove si sposa con una donna colta e intelligente, ma alcolizzata e già divorziata; è un matrimonio brevissimo, tanto che dopo una settimana apparentemente serena lei è partita per l’America. In cerca di chissà cosa e di quali nuovi incontri, Michele decide di andare a Bruges dove in una manifestazione viene accoltellato da dei fascisti non identificati e muore. Con questa perdita inspiegabile si conclude il romanzo, lasciando la madre e le sorelle nello sgomento e nello stupore. L’ultima lettera da Leeds è inviata da Osvaldo che è stato a casa di Michele, ma di lui c’era ben poco, solo una maglietta cenciosa: «una strana, gelida, desolata consolazione».
Si tratta di una famiglia piuttosto sconclusionata, non si capisce di cosa vivano; ad un certo punto la madre riflette e pensa di non aver saputo educare il figlio e neppure le figlie: «troppo spesso mi sentivo e mi sento una persona che non mi è simpatica. Per educare un altro bisogna avere nei confronti di sé stessi almeno un poco di fiducia e di simpatia». A proposito della vita confusa di Michele il 9 aprile gli scrive: «sento che la tua vita è diversa da come immagino, e così la mia fantasia è sempre più sfiduciata e più fiacca nell’intrecciare i suoi arabeschi sopra di te». In una lettera significativa, Angelica ammette che «ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé e qualche volta fortemente attratto dal vagabondare e dal respirare niente altro che la propria solitudine, e allora in questa zona ognuno di noi può trasferirsi per capirti». «Romanzo senza uomini ― scrive Cesare Garboli nell’Introduzione ― o dove gli uomini sono troppo infantili o troppo esausti per sopravvivere, è una vicenda attraversata da un crescente, misterioso senso di freddo», del resto ― aggiunge ― «solo nel disfacimento di esistenze senza via d’uscita, nella consapevolezza impotente della propria miseria ha sede il futuro degli altri».
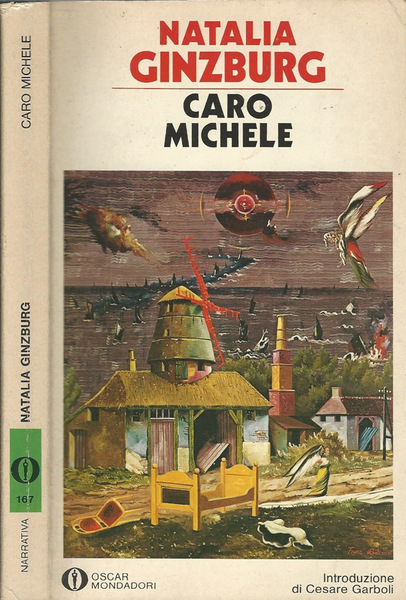
Successivamente viene edito Famiglia (Einaudi, 1977), suddiviso in due racconti lunghi: Famiglia e Borghesia che già dai titoli ci portano ai temi cari della scrittrice. Vicende di disgregazione e di smarrimento nella Roma dell’epoca in cui i personaggi si perdono e si ritrovano nella loro mediocrità, mentre la memoria riporta frammenti di nostalgia di esistenze banali, narrate con occhio asciutto e oggettività. Di particolare interesse il rapporto degli anti-eroi protagonisti con gli oggetti appartenenti all’uso quotidiano, con i cibi, con i propri animali domestici e l’utilizzo insistito dell’enumerazione e dell’iterazione, con frasi principali o coordinate brevi e brevissime, frammentate. Ecco un periodo esemplare in tal senso: «Ilaria morì nella notte. Aurora, chiamata da Pietro, giunse alla clinica quando era già morta. Aurora e Pietro si abbracciarono strettamente. Venne la Rirì e pianse».
E ancora, riguardo al rapporto affettuoso con gli animali di casa: «Aurora disse che voleva portare via con sé la gatta Ninna-nanna e i gattini. Essi le ricordavano Ilaria. [… sistemò] tutti i gatti in un grande cesto apposito […] a forma di pagoda, con una finestrella». E, a proposito di descrizione di oggetti, limitandoci alla pagina finale di Borghesia, troviamo una vecchia auto dai «parafanghi acciaccati», il «fazzoletto nero legato al mento» sul capo della Rirì, la «logora giacca amaranto» di Pietro, ma anche dettagli precisi sul suo aspetto fisico: «la testa alta, grigia e delicata, i denti bianchi, gli occhi asciutti e severi» di un uomo osservato nella sua oggettiva bellezza.

Uno dei libri più interessanti di Natalia Ginzburg, ben diverso da tutti gli altri essendo un’opera di saggistica, è La famiglia Manzoni (Einaudi, 1983) in cui ricostruisce le vite intrecciate dello scrittore con la famiglia: la madre, il padre che gli dà il cognome, il padre putativo, le mogli, la numerosa figliolanza. Lo fa attraverso lettere e documenti, senza ricostruzioni fantasiose o rielaborazioni narrative, in una cronaca rigorosa, persino fredda e spietata. «Volevo che i fatti parlassero da sé», afferma. Quello che emerge è il vero volto dell’uomo Alessandro, ben diverso dall’immagine che potremmo averne tratto dalle opere letterarie e, soprattutto, dal romanzo. Quanto dal suo capolavoro appare sereno, equilibrato, saggio, di animo gentile, tanto nella realtà era invece misantropo, ossessionato da mille malanni (più immaginari che reali), egoista, pauroso. «Strano, tortuoso, complesso», lo definisce l’autrice. È sconcertante scoprire come non sia stato un buon padre, come non sia stato un buon marito nei confronti della prima moglie, Enrichetta, fragile e perennemente incinta, come soprattutto pensasse a sé e al proprio benessere, mentre ad esempio la figlia Matilde gravemente malata lo invocava da lontano. Sempre utile ricordare alcuni dati oggettivi: Manzoni vive dal 1785 al 1873; Enrichetta Blondel dal 1791 al 1833: dalle nozze avvenute nel 1808, quando era una ragazzina, a tre anni prima della morte prematura ha 9 fra figli e figlie. Di tutta questa prole sopravvivono al padre solo Enrico e Vittoria, gli altri muoiono per lo più giovani o giovanissimi: Giulia (Giulietta), appena sposata, a 26 anni, come pure Cristina e Matilde, Sofia a 28 anni e Clara a due. Filippo ne aveva 42, Pietro 60. Il padre, eternamente malato e sofferente di acciacchi veri e presunti, a 88!
Commenta giustamente l’autrice che Manzoni non ha saputo essere un buon padre perché gli è mancata una figura di riferimento; il caso gli porterà dei padri putativi, come Carlo Imbonati, Fauriel, Rosmini. «Libero e leggero e allegro, con i propri figli veri, egli non lo era mai. […] Non era mai naturale e semplice, con i figli veri, se non quando era, per il loro comportamento o per le disgrazie che li colpivano, del tutto disperato. […] non custodiva dentro di sé nessuna immagine paterna: il ricordo del vecchio Don Pietro, impacciato e cupo, non gli destava nella memoria se non un carico di perplessità e di antichi, non mai sepolti rimorsi». L’unico figlio a cui si appoggiava era Pietro, mentre riusciva ad essere spontaneo, gioioso, naturale con Stefano, il figlio di Teresa, la seconda moglie, forse perché era giovane, libero e sano, con lui non doveva fare “il padre”, dispensatore di rimproveri, lodi, sermoni, consigli, scuse, risentimenti. Non doveva preoccuparsi delle precarie condizioni di salute né dell’estrema fragilità. D’altra parte basta scorrere i Promessi sposi per notare come manchino le figure paterne: Renzo e Lucia sono orfani; se un padre c’è, è terribile e crudele come il principe, padre di Gertrude. Il sarto potrebbe essere un buon genitore, nella sua semplicità, ma è un modello distante dai due sposi promessi e già adulti che trovano invece sul loro commino padri sostitutivi, mandati dalla provvidenza, come fra Cristoforo e il cardinale Borromeo, persino l’Innominato, dopo la redenzione.
Un libro raccomandabile davvero, ricco e documentato, ma scorrevole e punteggiato da argute osservazioni, indispensabile per chi voglia avvicinarsi all’umanità di Manzoni, facendolo scendere dal piedistallo su cui la letteratura lo ha collocato.
La città e la casa (Einaudi, 1984), ultima opera di Natalia Ginzburg, è un nuovo romanzo epistolare. Così lo presenta l’autrice:«Mi auguro e spero che, nelle vicende e nelle fisionomie delle persone che si scambiano queste lettere, possa riflettersi un poco della vita dei nostri giorni. Ma la vita dei nostri giorni, trovo sia difficile, raccontarla. Perciò se vi si rifletterà, vi si rifletterà in modo esiguo, estremamente frammentario e parziale, e come nelle schegge d’uno specchio rotto. Devo dire che, scrivendo romanzi, ho sempre avuto la sensazione d’avere in mano degli specchi rotti, e tuttavia sempre speravo di poter ricomporre finalmente uno specchio intiero. Ma non mi è mai successo e via via che andavo avanti a scrivere la speranza s’allontanava. Questa volta però, fin dal principio, non speravo nulla. Lo specchio era rotto e io sapevo che ricomporne i pezzi mi sarebbe stato impossibile. Non avrei avuto mai il bene di avere davanti a me uno specchio intiero».
Nella produzione della scrittrice trovano un posto di rilievo anche i testi teatrali; vanno segnalate in particolare le commedie: Ti ho sposato per allegria (1965) e Paese di mare (1972). La prima fu un grande successo: composta per l’attrice Adriana Asti, debuttò al teatro Gobetti di Torino il 14 maggio 1966 per la regia di Luciano Salce, il quale realizzò l’anno successivo un film con Monica Vitti nel ruolo della protagonista Giuliana.
Significative le traduzioni soprattutto dal francese che mettono in luce le sue predilezioni; si va dal bellissimo romanzo Il silenzio del mare di Vercors a classici come Una vita di Maupassant, La strada di Swann, Madame Bovary.
Per la saggistica va citato: Mai devi domandarmi (Garzanti, 1970) che contiene prevalentemente articoli comparsi sul quotidiano La Stampa, a testimonianza della sua costante attività di giornalista, per varie testate.

A trent’anni dalla scomparsa, possiamo concludere questa analisi complessiva delle opere di Natalia Ginzburg evidenziando in particolare la sapienza del suo sguardo sull’universo femminile, delineato in mille sfaccettature, sempre al centro dei suoi scritti che hanno ancora molto da regalarci.