Nata a Palermo il 14 luglio 1916, vive buona parte della vita a Torino iniziando precocemente a cimentarsi con la scrittura. Dopo il diploma liceale, frequenta l’università ma interrompe gli studi senza laurearsi. Nel 1938 sposa l’intellettuale antifascista e docente di Letteratura russa Leone Ginzburg, a breve lo seguirà al confino, intanto dall’unione nascono due figli e una figlia. Per la sua attività svolta a Roma durante la Resistenza, Leone viene catturato e sottoposto a torture, per cui muore il 5 febbraio 1944. La scrittrice nel dopoguerra lavora a lungo alla redazione della casa editrice Einaudi con cui mantiene nel tempo un fruttuoso sodalizio, intanto scrive romanzi e racconti, fa traduzioni, collabora a riviste e quotidiani. Nel 1950 sposa l’anglista Gabriele Baldini che la lascerà vedova nel 1969. Per lei inizia una fase di maggiore impegno sociale e politico, tanto che fra il 1983 e il 1987 sarà deputata per il Partito comunista italiano. Muore a Roma, dove viveva da tempo, l’8 ottobre 1991.
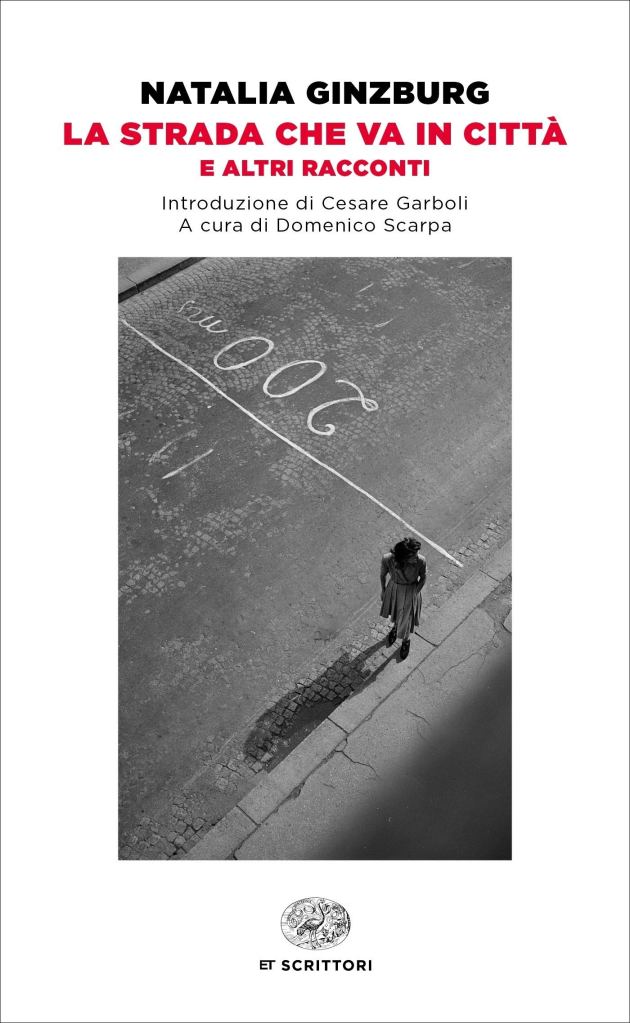
L’opera di esordio di Natalia Levi Ginzburg è il romanzo breve La strada che va in città, scritto a soli 24 anni e pubblicato da Einaudi nel 1942 con lo pseudonimo di Alessandra Tornimparte, ristampato tre anni dopo con il suo nome. È la storia di una ragazza di campagna che vuole emanciparsi, cercando nella città la sua via di fuga e la trova in un matrimonio di interesse, senza amore. Proprio durante la scorsa estate un adattamento teatrale è stato portato in scena dall’attrice Valentina Cervi per la regia di Iaia Forte.
È stato così (Einaudi, 1947; premio letterario Tempo) è ancora un romanzo breve da cui è stato tratto un film per la tv in due puntate diretto da Tomaso Sherman nel 1977. L’opera fu composta a Torino e vi si colloca, con buona probabilità. Di nuovo al centro troviamo una giovane donna, sposata senza gioia, legata ad un uomo infedele; già emergono alcuni caratteri della scrittura di Ginzburg: asciutta, sintetica, oggettiva ma attenta alla psicologia dei personaggi femminili, immersi nella banalità della vita quotidiana.
Tutti i nostri ieri (Einaudi, 1952) è un romanzo ben più ampio dei due precedenti, ambientato fra il fascismo e la fine della Seconda guerra mondiale, in due diverse località italiane, al nord e al sud. La nota sul retro di copertina avverte: «qui la voce [narrante] è fissata in una specie di immaturità attonita e sorda, e un’unica cadenza, quasi un canto monodico, percorre tutto il libro». È proprio così: le pagine si susseguono dense di nomi, personaggi, piccoli fatti senza storia, quasi del tutto prive di dialoghi, «tra le proposizioni indirette di un flusso sintattico rudimentale» e, a lungo andare, una certa monotonia prende il sopravvento, tanto che l’opera non risulta pienamente convincente.

Valentino (Einaudi, 1957; premio Viareggio) è un libro che contiene tre storie: la prima è il racconto lungo in cui la voce narrante è Caterina, una modesta insegnante sorella di colui che dà il titolo e diviene il vero protagonista. Su di lui c’erano tante aspettative in famiglia, invece si rivela un fallito e un mantenuto che ha trovato la sua occasione d’oro sposando una donna più vecchia, brutta, grassa, ma ricchissima. Si è inoltre legato, in maniera ambigua, a un individuo suo pari, un inglese di nome Kit. Quando la sorte cambia, Caterina rimane comunque al suo fianco, presenza amorevole e disinteressata nei cui atti e pensieri si svelano il lirismo e la fine capacità introspettiva della scrittrice. Il secondo racconto, assai breve, ma molto bello, La madre, è incentrato all’interno di un nucleo familiare in cui una giovane mamma, rimasta vedova, finisce con il suicidarsi di fronte al suo personale “male di vivere”. Inadatta e fragile, «si faceva imbrogliare dal macellaio e filava via in bicicletta, e fumava e sbagliava le strade e singhiozzava di notte»; ben presto fu per i due figli solo un lontano e vago ricordo. Il terzo, quasi un romanzo, si intitola Sagittario. Di nuovo una ragazza, ventitreenne, studente di Lettere parla della propria famiglia, che vede al centro la madre, iperattiva e piena di idee, insieme alla sorella Giulia con il marito medico. Una ampia analessi narra i precedenti: la vedovanza, la noiosa vita a Dronero, la fragilità della giovane, le premure del bravo dottore polacco, le loro nozze senza amore, il trasferimento in città. Il titolo merita una spiegazione: questo nome dovrebbe essere dato all’attività vagheggiata dalla madre, una galleria d’arte, da realizzare in società con una donnetta con «la zazzera color fieno», conosciuta da poco, con ambizioni di pittrice. Fra chiacchiere, incontri, piccoli episodi quotidiani, personaggi per lo più femminili dalle esistenze mediocri, nella assoluta mancanza di dialoghi, la vicenda assume verso l’epilogo toni tragici: la signora Fontana era una imbrogliona esperta e ruba i soldi della madre (che non ha nome), quei cinque milioni che dovevano servire per aprire la galleria, e Giulia muore nel parto. «Con le labbra spianate in un vago sorriso gentile e malinconico, Giulia sembrava dire addio a questa vita che non era stata capace di amare». Mentre osserva il nipotino, «rosso rosso, con lunghi e biondi capelli polacchi», la madre finalmente capisce il senso del perenne sorriso sul volto della figlia, giudicata incapace, passiva, inconcludente, era il sorriso di chi vive in disparte e desidera solo ritornare nell’ombra. Un finale dunque che in qualche modo riscatta la donna e, ancora una volta, fa emergere l’abilità della scrittrice nel penetrare a fondo nell’animo femminile.
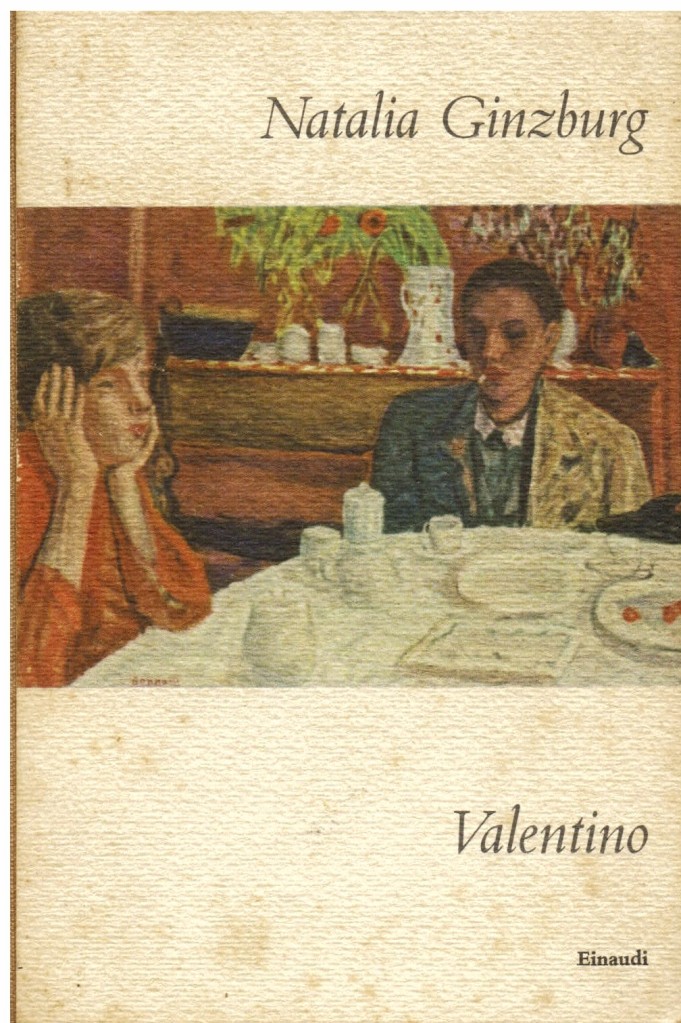
Le voci della sera, uscito nel 1961 da Einaudi, precede di due anni l’opera più compiuta e memorabile di Ginzburg che nel corso del tempo non mi sono stancata di rileggere, con gusto sempre rinnovato. Questo romanzo breve per certi versi la anticipa, pur essendo di totale fantasia, come afferma l’autrice: luoghi immaginari, personaggi immaginari che però dice di aver amato molto, «come fossero veri». La anticipa nei vivaci dialoghi, nell’ambientazione in paesini del nord Italia (Piemonte?), nelle precise descrizioni, nelle divertenti espressioni popolari («sei sempre una ciula», «quel babbaccio là», «vecchia bergianna», «martuffio»), nei personaggi curiosi e originali, come il padrone della fabbrica tenacemente socialista o suo figlio, che più che suonare «bela». Insistito poi l’uso, tutto settentrionale, dell’articolo con i nomi propri: «Dopo la Gemmina, il Vincenzino. Poi il Mario, la Raffaella, e ultimo il Tommasino». Anche qui la voce narrante è in prima persona, femminile: una ventisettenne laureata in Lettere che vive ancora con i genitori, di cui sapremo il nome, Elsa, solo a pagina 85. È lei dunque che ci racconta delle famiglie note dei dintorni, del fratello e della sorella che vivono in due diversi continenti, della banalità dell’esistenza quotidiana, di cosa accadde durante e dopo la guerra; di sé comincia a parlare a pagina 82, svelando la relazione con Tommasino, tenuta segreta. I due arrivano a un passo dal matrimonio, ma poi si rendono conto di non essere felici insieme e si lasciano. Ha sintetizzato efficacemente Pietro Citati: «Ma, come sempre, il più lieve e lieto dei suoi libri è anche quello dove lo strazio è più profondo, dove l’elegia si piega più accoratamente sulle cose che si perdono, sui sentimenti così fragili che muoiono, appena qualcuno li porta alla luce».

Nel 1962 viene dato alle stampe da Einaudi un volumetto esile, ma gustoso: si tratta di Le piccole virtù che raccoglie saggi e articoli già apparsi qua e là, tuttavia piuttosto aderenti al genere della narrativa. Di ciascuno è essenziale conoscere la data e il luogo di composizione dal momento che vi si legano in modo indissolubile; citiamo come esempio il primo che risale al lontano 1944 e ricorda il tempo appena vissuto in Abruzzo, al confino, in un paese misero dove esistevano solo due stagioni: l’inverno e l’estate. Episodi semplici, vita di ogni giorno, la guerra, il proprio mestiere, la forza del silenzio, le piccole e le grandi virtù da tramandare, scarpe vecchie e rotte da un lato ed elogio dell’Inghilterra, Paese «altamente civile», dall’altro. Ma voglio segnalare almeno due perle di questa collana: un racconto mi è capitato di farlo conoscere alle mie classi come esempio straordinario e umoristico di antitesi all’interno della coppia (Lui e io), l’altro perché è quanto di più bello sia stato scritto dell’uomo Cesare Pavese (Ritratto d’un amico); anche solo queste poche pagine valgono la lettura.

Nel 1963 arriva dunque l’opera più amata, nota, apprezzata della scrittrice: Lessico famigliare che le valse il premio Strega; un libro di memorie, ancora una volta pubblicato da Einaudi, dove ciò che viene narrato è vero e reale, ma segue l’onda instabile e vaga dei ricordi, «con vuoti e lacune», «esili barlumi e schegge», tuttavia è pur sempre la storia della sua famiglia. Basta la prima pagina per entrare nel vivo di un nucleo familiare in cui il padre, il prof. Giuseppe Levi, ha un ruolo fondamentale per i suoi comportamenti, le sue bizzarrie, il suo aspetto, il suo linguaggio originalissimo che fa da filo conduttore dell’intero sviluppo narrativo. «Malagrazie», «sbrodeghezzi», «potacci», «loghi», «sempio», «negro» (nel senso di impacciato, goffo), «negrigura»: sono alcune delle curiose espressioni utilizzate per rimproverare, guidare, raddrizzare la moglie, i tre figli, le due figlie, la cameriera. Le amiche di Lidia, la moglie che ama circondarsi di giovani spose, sono «le babe» per le quali va comunque preparato del «trattamento» (tè e biscotti, rigorosamente niente alcol), le chiacchiere sono «fufignezzi», i quadri di Casorati «sgarabazzi»: un lessico unico, esclusivo della famiglia, che fa scrivere all’autrice: «Una di quelle frasi o parole, ci farebbe riconoscere l’uno con l’altro, noi fratelli, nel buio d’una grotta, fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino». Sicuramente questo aspetto è centrale nel testo, ma non è certo l’unico: spesso le situazioni sono umoristiche o risolte in tal modo (come le sfiancanti gite in montagna), i dialoghi sono vivacissimi e modellati chiaramente sul parlato quotidiano, ricordi e aneddoti si fondono con episodi legati alle vicende dell’epoca. Di tutto ciò infatti Natalia è testimone, una spettatrice nell’ombra che osserva e commenta in prima persona, fino dalla giovinezza, e si trova a raccontarci di personaggi della cultura, della politica, della storia che ormai appartengono a tutti/e noi: da Cesare Pavese a Carlo Levi, da Turati ai fratelli Rosselli, dalla famiglia Olivetti a Einaudi, da Pajetta al suo futuro marito Leone. Qui si vive all’interno di una realtà colta, cittadina, agiata, nel cuore di Torino, con un padre docente universitario di Anatomia, fra amicizie e parentele tenacemente antifasciste, ma del pericolo imminente talvolta si sente una eco, che diventerà concretezza ineluttabile quando Natalia si troverà moglie e madre, fino alla tragedia che sconvolgerà le singole esistenze e l’intero Paese.

Caro Michele (Mondadori, 1973), da cui è stato tratto il film di Mario Monicelli del 1976 con Mariangela Melato, è una sorta di romanzo epistolare, con pochi raccordi narrativi, ambientato fra 1970 e 1971. Si apre con Adriana che scrive a Michele, il figlio di 22 anni, esortandolo a visitare il padre malato, da cui è separata da tanto tempo; lei si è da poco trasferita in una casa isolata, in campagna, con le figlie gemelle adolescenti, mentre altre due figlie sono più grandi e già autonome. Nel susseguirsi della storia, in cui comunque gli eventi sono pochi e dettati dalla quotidianità, si trovano via via le risposte di Michele e le lettere di altri personaggi. Incontriamo Mara (che ha appena avuto un bambino, forse figlio di Michele), una sbandata senza casa e senza legami, in cerca di protezione e aiuto; scrive poi Osvaldo, un amico; scrivono le figlie maggiori: Angelica e Viola; scrivono pure conoscenti occasionali. Quando il padre muore, Michele è lontano, vive a Londra: è un ragazzo inquieto, senza ideali, senza un lavoro. Si trasferisce in seguito a Leeds, dove si sposa con una donna colta e intelligente, ma alcolizzata e già divorziata; è un matrimonio brevissimo, tanto che dopo una settimana apparentemente serena lei è partita per l’America. In cerca di chissà cosa e di quali nuovi incontri, Michele decide di andare a Bruges dove in una manifestazione viene accoltellato da dei fascisti non identificati e muore. Con questa perdita inspiegabile si conclude il romanzo, lasciando la madre e le sorelle nello sgomento e nello stupore. L’ultima lettera da Leeds è inviata da Osvaldo che è stato a casa di Michele, ma di lui c’era ben poco, solo una maglietta cenciosa: «una strana, gelida, desolata consolazione».
Si tratta di una famiglia piuttosto sconclusionata, non si capisce di cosa vivano; ad un certo punto la madre riflette e pensa di non aver saputo educare il figlio e neppure le figlie: «troppo spesso mi sentivo e mi sento una persona che non mi è simpatica. Per educare un altro bisogna avere nei confronti di sé stessi almeno un poco di fiducia e di simpatia». A proposito della vita confusa di Michele il 9 aprile gli scrive: «sento che la tua vita è diversa da come immagino, e così la mia fantasia è sempre più sfiduciata e più fiacca nell’intrecciare i suoi arabeschi sopra di te». In una lettera significativa, Angelica ammette che «ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé e qualche volta fortemente attratto dal vagabondare e dal respirare niente altro che la propria solitudine, e allora in questa zona ognuno di noi può trasferirsi per capirti». «Romanzo senza uomini ― scrive Cesare Garboli nell’Introduzione ― o dove gli uomini sono troppo infantili o troppo esausti per sopravvivere, è una vicenda attraversata da un crescente, misterioso senso di freddo», del resto ― aggiunge ― «solo nel disfacimento di esistenze senza via d’uscita, nella consapevolezza impotente della propria miseria ha sede il futuro degli altri».
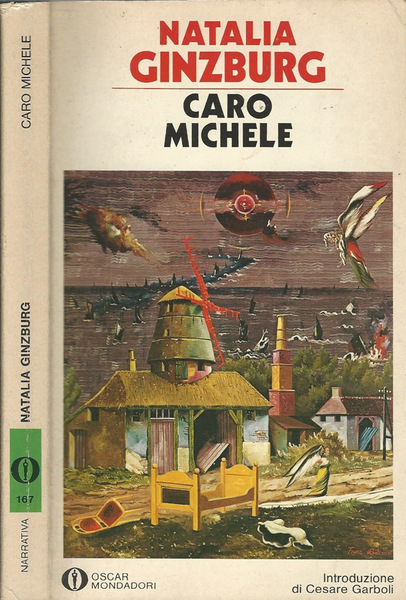
Successivamente viene edito Famiglia (Einaudi, 1977), suddiviso in due racconti lunghi: Famiglia e Borghesia che già dai titoli ci portano ai temi cari della scrittrice. Vicende di disgregazione e di smarrimento nella Roma dell’epoca in cui i personaggi si perdono e si ritrovano nella loro mediocrità, mentre la memoria riporta frammenti di nostalgia di esistenze banali, narrate con occhio asciutto e oggettività. Di particolare interesse il rapporto degli anti-eroi protagonisti con gli oggetti appartenenti all’uso quotidiano, con i cibi, con i propri animali domestici e l’utilizzo insistito dell’enumerazione e dell’iterazione, con frasi principali o coordinate brevi e brevissime, frammentate. Ecco un periodo esemplare in tal senso: «Ilaria morì nella notte. Aurora, chiamata da Pietro, giunse alla clinica quando era già morta. Aurora e Pietro si abbracciarono strettamente. Venne la Rirì e pianse».
E ancora, riguardo al rapporto affettuoso con gli animali di casa: «Aurora disse che voleva portare via con sé la gatta Ninna-nanna e i gattini. Essi le ricordavano Ilaria. [… sistemò] tutti i gatti in un grande cesto apposito […] a forma di pagoda, con una finestrella». E, a proposito di descrizione di oggetti, limitandoci alla pagina finale di Borghesia, troviamo una vecchia auto dai «parafanghi acciaccati», il «fazzoletto nero legato al mento» sul capo della Rirì, la «logora giacca amaranto» di Pietro, ma anche dettagli precisi sul suo aspetto fisico: «la testa alta, grigia e delicata, i denti bianchi, gli occhi asciutti e severi» di un uomo osservato nella sua oggettiva bellezza.

Uno dei libri più interessanti di Natalia Ginzburg, ben diverso da tutti gli altri essendo un’opera di saggistica, è La famiglia Manzoni (Einaudi, 1983) in cui ricostruisce le vite intrecciate dello scrittore con la famiglia: la madre, il padre che gli dà il cognome, il padre putativo, le mogli, la numerosa figliolanza. Lo fa attraverso lettere e documenti, senza ricostruzioni fantasiose o rielaborazioni narrative, in una cronaca rigorosa, persino fredda e spietata. «Volevo che i fatti parlassero da sé», afferma. Quello che emerge è il vero volto dell’uomo Alessandro, ben diverso dall’immagine che potremmo averne tratto dalle opere letterarie e, soprattutto, dal romanzo. Quanto dal suo capolavoro appare sereno, equilibrato, saggio, di animo gentile, tanto nella realtà era invece misantropo, ossessionato da mille malanni (più immaginari che reali), egoista, pauroso. «Strano, tortuoso, complesso», lo definisce l’autrice. È sconcertante scoprire come non sia stato un buon padre, come non sia stato un buon marito nei confronti della prima moglie, Enrichetta, fragile e perennemente incinta, come soprattutto pensasse a sé e al proprio benessere, mentre ad esempio la figlia Matilde gravemente malata lo invocava da lontano. Sempre utile ricordare alcuni dati oggettivi: Manzoni vive dal 1785 al 1873; Enrichetta Blondel dal 1791 al 1833: dalle nozze avvenute nel 1808, quando era una ragazzina, a tre anni prima della morte prematura ha 9 fra figli e figlie. Di tutta questa prole sopravvivono al padre solo Enrico e Vittoria, gli altri muoiono per lo più giovani o giovanissimi: Giulia (Giulietta), appena sposata, a 26 anni, come pure Cristina e Matilde, Sofia a 28 anni e Clara a due. Filippo ne aveva 42, Pietro 60. Il padre, eternamente malato e sofferente di acciacchi veri e presunti, a 88!
Commenta giustamente l’autrice che Manzoni non ha saputo essere un buon padre perché gli è mancata una figura di riferimento; il caso gli porterà dei padri putativi, come Carlo Imbonati, Fauriel, Rosmini. «Libero e leggero e allegro, con i propri figli veri, egli non lo era mai. […] Non era mai naturale e semplice, con i figli veri, se non quando era, per il loro comportamento o per le disgrazie che li colpivano, del tutto disperato. […] non custodiva dentro di sé nessuna immagine paterna: il ricordo del vecchio Don Pietro, impacciato e cupo, non gli destava nella memoria se non un carico di perplessità e di antichi, non mai sepolti rimorsi». L’unico figlio a cui si appoggiava era Pietro, mentre riusciva ad essere spontaneo, gioioso, naturale con Stefano, il figlio di Teresa, la seconda moglie, forse perché era giovane, libero e sano, con lui non doveva fare “il padre”, dispensatore di rimproveri, lodi, sermoni, consigli, scuse, risentimenti. Non doveva preoccuparsi delle precarie condizioni di salute né dell’estrema fragilità. D’altra parte basta scorrere i Promessi sposi per notare come manchino le figure paterne: Renzo e Lucia sono orfani; se un padre c’è, è terribile e crudele come il principe, padre di Gertrude. Il sarto potrebbe essere un buon genitore, nella sua semplicità, ma è un modello distante dai due sposi promessi e già adulti che trovano invece sul loro commino padri sostitutivi, mandati dalla provvidenza, come fra Cristoforo e il cardinale Borromeo, persino l’Innominato, dopo la redenzione.
Un libro raccomandabile davvero, ricco e documentato, ma scorrevole e punteggiato da argute osservazioni, indispensabile per chi voglia avvicinarsi all’umanità di Manzoni, facendolo scendere dal piedistallo su cui la letteratura lo ha collocato.
La città e la casa (Einaudi, 1984), ultima opera di Natalia Ginzburg, è un nuovo romanzo epistolare. Così lo presenta l’autrice:«Mi auguro e spero che, nelle vicende e nelle fisionomie delle persone che si scambiano queste lettere, possa riflettersi un poco della vita dei nostri giorni. Ma la vita dei nostri giorni, trovo sia difficile, raccontarla. Perciò se vi si rifletterà, vi si rifletterà in modo esiguo, estremamente frammentario e parziale, e come nelle schegge d’uno specchio rotto. Devo dire che, scrivendo romanzi, ho sempre avuto la sensazione d’avere in mano degli specchi rotti, e tuttavia sempre speravo di poter ricomporre finalmente uno specchio intiero. Ma non mi è mai successo e via via che andavo avanti a scrivere la speranza s’allontanava. Questa volta però, fin dal principio, non speravo nulla. Lo specchio era rotto e io sapevo che ricomporne i pezzi mi sarebbe stato impossibile. Non avrei avuto mai il bene di avere davanti a me uno specchio intiero».
Nella produzione della scrittrice trovano un posto di rilievo anche i testi teatrali; vanno segnalate in particolare le commedie: Ti ho sposato per allegria (1965) e Paese di mare (1972). La prima fu un grande successo: composta per l’attrice Adriana Asti, debuttò al teatro Gobetti di Torino il 14 maggio 1966 per la regia di Luciano Salce, il quale realizzò l’anno successivo un film con Monica Vitti nel ruolo della protagonista Giuliana.
Significative le traduzioni soprattutto dal francese che mettono in luce le sue predilezioni; si va dal bellissimo romanzo Il silenzio del mare di Vercors a classici come Una vita di Maupassant, La strada di Swann, Madame Bovary.
Per la saggistica va citato: Mai devi domandarmi (Garzanti, 1970) che contiene prevalentemente articoli comparsi sul quotidiano La Stampa, a testimonianza della sua costante attività di giornalista, per varie testate.

A trent’anni dalla scomparsa, possiamo concludere questa analisi complessiva delle opere di Natalia Ginzburg evidenziando in particolare la sapienza del suo sguardo sull’universo femminile, delineato in mille sfaccettature, sempre al centro dei suoi scritti che hanno ancora molto da regalarci.

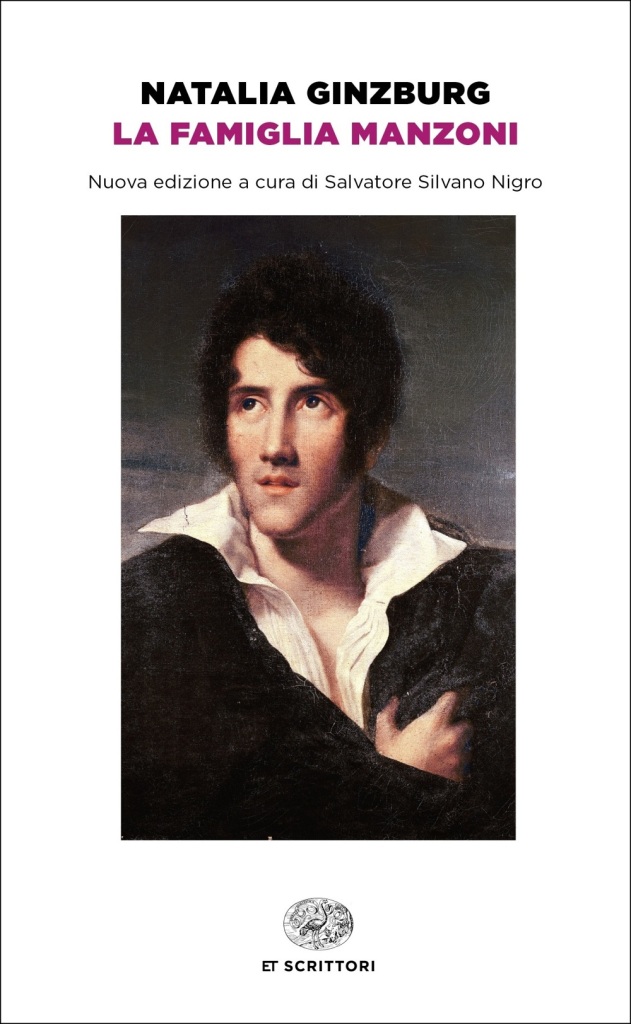
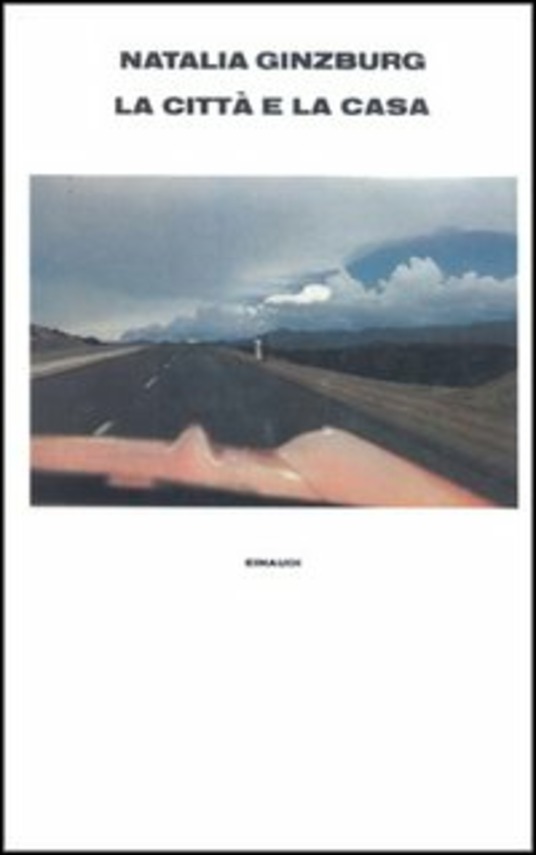
Nessun commento:
Posta un commento