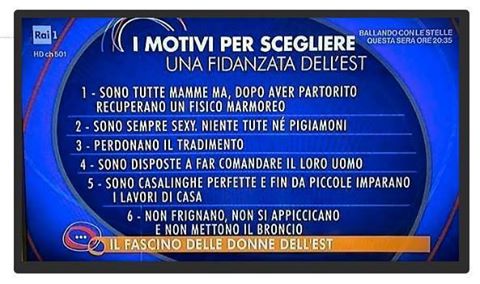Sono trascorsi così pochi giorni dalla notizia della condanna a Vicenza di una giovane donna rea di procurato aborto, che occorrerebbe meglio delineare i contorni di questa vicenda, di modo che non venga annoverata tra gli innumerevoli casi di cronaca nera. In primo luogo perché per l’ennesima volta si accendono i riflettori mediatici sul fenomeno degli aborti illegali, secondariamente perché ad essere punita è chi da minorenne aveva praticato altre tre interruzioni di gravidanza sempre con la stessa metodologia, quale il ricorso a dosi massicce di un farmaco antispastico. Una prassi sempre più diffusa questa, ossia acquistare il misopristolo che, assunto in maniera impropria, comporta l’espulsione del prodotto del concepimento. Non sempre però questo particolare aborto farmacologico è privo di conseguenze negative, come la metrorragia, il sanguinamento dell’utero non dovuto a mestruazione.
Come accaduto due anni fa a Genova, in un episodio che indusse la Procura della Repubblica cittadina ad aprire un’indagine sulle preoccupanti interruzioni di gravidanze attraverso il Cytotec, utilizzato sempre di più sia da minorenni che da prostitute. I magistrati genovesi erano stati allertati dal caso di due adolescenti che, temendo una gravidanza indesiderata, scoprirono su internet che il suddetto farmaco anti ulcera avesse come effetto collaterale “le fortissime contrazioni dell’utero e un aborto quasi sicuro entro le prime nove settimane”. Indotta dal fidanzato la giovane donna assunse la dose consigliata da un blog, ossia nove compresse in una sola giornata. Ma le conseguenze furono, oltre all’aborto, dieci giorni di perdite di sangue, tanto da comportare il ricovero della ragazza in ospedale e la conseguente ammissione di avere utilizzato quel farmaco per interrompere la gravidanza.
L’anno scorso alcuni medici ed ostetriche sottoscrissero una lettera aperta alla Ministra Lorenzin per protestare contro l’aggravio economico che aumentava in maniera spropositata le sanzioni per chi abortisce clandestinamente, chiedendole di promuovere una seria campagna di monitoraggio su questo fenomeno sottostimato dallo stesso Governo.
Anche il gruppo di attiviste #ObiettiamoLaSanzione, nel richiedere la revoca della sanzione, sottolineò i rischi per la salute delle donne che ricorrono all’aborto farmacologico fai da te, chiedendo nel contempo anche una reale presa in carico del problema delle interruzioni di gravidanza fuori legge. Problema che ancora ad oggi il Ministero della Salute continua ad ignorare affermando nelle Relazioni parlamentari sullo stato di applicazione della legge 194 che il fenomeno dell’aborto clandestino si sarebbe mantenuto costante negli ultimi 10 anni. Avvenimenti come quello di Vicenza dimostrano invece il contrario e dovrebbero indurre le istituzioni ad intervenire a monte, soprattutto al riguardo del ricorso a tali prassi da parte degli adolescenti. Sempre più si appalesa conseguentemente la necessità di puntuali campagne informative che li vedano destinatari di una congrua ed opportuna educazione sessuale.
I consultori, a tal ruolo preposti, negli anni sono venuti a perdere questa specifica funzione per una serie di svariati motivi, lasciando conseguentemente scoperta la platea degli eventuali utenti giovanili, sempre più in balia dell’informazione fai da te. Approfondendo alcuni dati del 2010, difatti, si rileva che il 27% non usa alcun anticoncezionale, il 22% utilizza il metodo del coito interrotto, il 27% ricorre al preservativo ed il 18% alla pillola. Risulta alquanto evidente che circa la metà dei nostri teenagers non riesca a vivere consapevolmente la propria sessualità, preferendo rincorrere delle vere e proprie leggende metropolitane, quali che la lavanda alla coca–cola, al limone o all’aceto possa fungere da anticoncezionale. Senza contare il tam-tam che circola insistentemente sulla circostanza che fare l’amore in piedi riesca a non rendere incinte le ragazze. Proprio la vicenda della giovane donna condannata a Vicenza, denunciata nel 2015 a seguito di un malessere a scuola a cui conseguì il ricovero in ospedale per emorragia, induce a dare ragione a Marco Rossi, presidente dell'Associazione Italiana di Sessuologia ed Educazione Sessuale, quando sostiene che: «I ragazzi hanno informazioni sulla sessualità che derivano prevalentemente dai propri coetanei, e che i loro coetanei prendono da internet, senza gli strumenti per discernere il falso dal vero».
Non entrando nel merito di come e quanto si discuta in famiglia di tali temi, ma focalizzando l’attenzione sulle modalità con le quali la scuola pubblica italiana funzioni da agenzia educativa in tema di sessualità consapevole, c’è da dire che non esistono norme obbligatorie al riguardo. L’informazione è nelle mani di insegnanti volenterosi, che sopperiscono ad oltre un trentennio di coscienti scelte omissive da parte delle istituzioni competenti. Tutti i tentativi di introdurre per legge l’educazione sessuale nelle scuole sono miseramente naufragati nel mare magno di una preventiva opposizione da parte delle gerarchie ecclesiastiche e di alcune formazioni partitiche. Eppure un recente rapporto dell'Organizzazione mondiale della Sanità sugli impatti dell'educazione sessuale ha rivelato che, nei Paesi in cui è in vigore, essa ha determinato una diminuzione delle gravidanze adolescenziali e degli aborti, delle malattie sessualmente trasmissibili e dell'HIV, senza parlare degli ulteriori effetti nel tempo lungo per gli abusi sessuali e i casi di omofobia. In Italia, d’altronde, un’indagine dell’Osservatorio nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, predisposta nel 2013 su 1400 giovani di sette scuole diverse, ha appalesato in particolare che “il 19% degli adolescenti ha rapporti sessuali prima dei 14 anni, una cifra quasi raddoppiata rispetto alle stime dell’anno precedente: il problema è che il 73% dei ragazzi non conosce le principali malattie a trasmissione sessuale (Mts) e il 33% pensa che la loro incidenza sia trascurabile” (fonte Valigia blu).
Diventa, quindi, oltremodo colpevole che la classe politica italiana continui ad allontanare nel tempo la propria specifica responsabilità al proposito dell’adozione di programmi ministeriali in tema di educazione sessuale. Programmi che puntino a ritardare l’età del primo rapporto sessuale, a far diminuire la frequenza e il numero di rapporti con partner diversi, nonchè a determinare una maggiore prevenzione di rapporti sessuali a rischio. Non c’è altro tempo da perdere, perché evitare che succedano casi come quello di Vicenza dovrebbe indurre a prendere le giuste determinazioni al riguardo. Altrimenti a chi sui media ha definito la giovane donna in questione “professionista dell’aborto”, sarebbe da replicare che gli unici veri professionisti sono i legislatori rei del mancato avvio dell’educazione sessuale nelle scuole pubbliche italiane. Professionisti nel portare su di sé la responsabilità di un vuoto normativo che impedisce ai nostri adolescenti di acquisire quella consapevolezza adeguata ad evitare gravidanze indesiderate, malattie sessualmente trasmissibili e persino forme di sfruttamento, coercizione ed abuso.
http://www.noidonne.org/blog.php?ID=07904